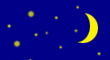I giovani lavoratori della conoscenza
(Italiano, 28 Gennaio 2008)
Questo documento è stato preparato da me e da Fiorello Cortiana per sollevare il problema del riconoscimento sociale dei lavoratori della conoscenza, categoria nuova, poco riconosciuta e assolutamente priva di protezione e di incentivi. Era pensato per una conferenza di imprenditori, ma resta una interessante esposizione di problemi su cui lavorare.
E' ormai riconosciuto che le speranze di crescita di un paese sviluppato sono legate all'innovazione di prodotto, di processo e di tecnologia; e quindi, in buona sostanza, alla quantità di conoscenza e di inventiva che circola nel sistema.
Ne consegue che le speranze di crescita di un paese come l'Italia sono fortemente legate a una specifica categoria sociale: quella dei giovani lavoratori della conoscenza. Giovani, perché l'innovazione – non solo quella evolutiva, ma soprattutto quella rivoluzionaria, dalle maggiori potenzialità di impatto sul mercato – dipende dalla capacità di pensare fuori dagli schemi e dalla disponibilità al rischio personale, due caratteristiche che mediamente diminuiscono con l'età; della conoscenza, perché in molti settori – dall'informatica ai servizi passando per la comunicazione – l'innovazione dipende ormai poco, almeno nelle fasi iniziali, dalla disponibilità di capitali, e molto di più dall'avere un'idea al passo con l'evoluzione del mercato globale, e dalla capacità di declinarla in una rete di relazioni su scala planetaria. E inoltre, lavoratori, nel senso che le imprese innovative devono correre più delle altre, né hanno rendite di posizione su cui contare per mantenersi; per cui la quantità di lavoro è garantita.
I giovani lavoratori della conoscenza sono una categoria molto ampia, ma possono essere ricondotti ad alcune tipologie principali. Molti sono tecnici, che lavorano per aziende private spesso di dimensione medio-piccola, con un rapporto dipendente nei fatti, ma precario nella forma. Alcuni sono ricercatori universitari, solitamente costretti a vivere di stenti e sovvenzioni paterne fino all'arrivo di una raccomandazione che gli permetta di ottenere un impiego pubblico. Infine vi è un numero crescente di schegge impazzite, professionisti che vivono di consulenze oppure mettono in piedi piccole imprese altamente specializzate.
Lavorare con la conoscenza è per molti versi un privilegio: la fatica fisica è ridotta, il piacere intellettuale è elevato, la noia è rara e si può godere in molti casi di una inebriante sensazione di libertà, che spesso coincide con l'assenza di orari e di vincoli, a parte le scadenze concordate con i clienti. Si lavora comunque parecchio, ma si sa che la ricompensa per il proprio lavoro, se ben fatto, non sarà intascata da nessun altro (a parte quel 60% che si prende lo Stato, ovviamente). In più, si gode di una vista privilegiata su molti fenomeni socioeconomici; alcuni individui giungono persino in posizioni dove possono influenzarli, tramite quegli eventi a valanga per cui un ventenne californiano inventa Napster per gioco e dieci anni dopo la multimiliardaria industria della musica è alla frutta, oppure per cui un paio di ragazzi fanno una tesi di laurea su un motore di ricerca, ci credono, trovano terreno fertile e meno di dieci anni dopo Google capitalizza centocinquanta miliardi di dollari.
Questi esempi mettono in evidenza come il paradigma stesso dell'economia sia, almeno nei settori con forte potenzialità di crescita, drammaticamente cambiato. Grazie alla globalizzazione e all'impatto profondo della rete globale, molti muri invisibili sono crollati; quello tra lavoro e tempo libero, quello tra imprenditore e dipendente, e persino quello tra politica ed economia, con i governi sempre più impotenti a dirigere le proprie società di fronte a logiche economiche internazionali. Una persona che è dipendente di una Università, ma che deve costantemente inventarsi nuovi progetti e nuovi stimoli per reperire fondi e dare un senso al proprio lavoro, è più un dipendente o più un imprenditore? E una persona che è contemporaneamente socio di una piccola impresa, libero professionista, consulente per grandi aziende, manager a gettone, può essere classificata?
Proprio per la sua crucialità, la categoria dei giovani lavoratori della conoscenza viene coltivata e coccolata in molte nazioni, anche con politiche di attrazione di talenti dall'estero. In Italia, invece, sono dolori: nel nostro Paese la classe dirigente ha ancora in testa il modello industriale del dopoguerra, in cui o si è lavoratore, o si è padrone, o al massimo si è professionista dentro un ordine riconosciuto; non è quindi che l'Italia disprezzi questo tipo di lavoratori, semplicemente non li concepisce. Di conseguenza, proprio una categoria così cruciale è completamente abbandonata dal sistema di welfare del Paese; è inquadrata dal fisco come lavoratore autonomo (quindi per definizione presunto evasore fiscale), pagando tasse e contributi elevati, per i quali però non riceve alcun servizio o tutela, perché non ricade in alcuna delle categorie sindacali e solitamente nemmeno in alcuna di quelle professionali o padronali.
In un paese diviso per caste, questi lavoratori sono i paria: magari con un lavoro gratificante e talvolta anche ben remunerati, ma privi di sicurezze ed esclusi da qualsiasi forma di assistenza e di rappresentanza politica e sociale.
Di conseguenza, in Italia questi lavoratori difficilmente sopravvivono; o si adeguano al sistema, perdendo presto le aspirazioni ad un lavoro innovativo per inserirsi in binari di carriera più consolidati ma anche molto meno utili per il Paese, o emigrano. Infatti, a velocità sempre più sconvolgente, negli ultimi vent'anni si è visto lo schema dell'emigrazione italiana cambiare drammaticamente: non una emigrazione – come è sempre stata – di lavoratori poco qualificati, tradizionalisti e semi-analfabeti, verso territori a maggior crescita; ma una emigrazione dei migliori talenti, degli innovatori e degli intraprendenti, verso territori dove ci sia maggior possibilità di crescere e di essere riconosciuti. Questo è il pattern di emigrazione tipico delle nazioni africane, e questo cambiamento da solo dovrebbe essere un segnale estremamente preoccupante; se non fosse che la nostra politica non se ne è nemmeno accorta, come dimostra il clamoroso errore di stima di Berlusconi sull'identikit e quindi sul voto degli italiani all'estero alle ultime elezioni.
A chi sia interessato a rilanciare lo sviluppo economico e sociale dell'Italia, si pone quindi come problema urgente quello di creare le condizioni perlomeno per trattenere i nostri migliori talenti, e magari per cominciare ad attrarre quelli degli altri. Purtroppo però tali condizioni richiedono modifiche radicali della mentalità degli italiani; una rivoluzione sociale per la quale forse, nell'attuale clima di sfascio, esistono le premesse, ma che è certamente molto difficile da realizzare.
Per prima cosa, è necessario mettere al centro di ogni dinamica sociale la meritocrazia. In un sistema chiuso, può succedere che tre studenti poco capaci sequestrino lo studente migliore nel bagno della scuola e lo torturino fino a convincerlo a fare i compiti anche per loro, in mezzo agli applausi di tutta la classe (è successo pochi giorni fa vicino a Grosseto). La stessa cosa è sempre successa sul lavoro; in molte aziende, il lavoratore migliore viene mobbato dai colleghi perché lavori di meno e non metta troppo in evidenza la pigrizia o la mediocrità altrui. Quando anche ciò non succede, di solito in Italia le politiche retributive e di carriera sono prevalentemente slegate dal merito, e basate teoricamente su una equità formale che premia i peggiori, e di fatto su raccomandazioni e parentele.
Al di là di qualsiasi considerazione etica, è evidente che un sistema di selezione sociale di questo tipo provoca un appiattimento verso il basso, e quindi rende le aziende italiane non competitive rispetto alle altre società nazionali che premiano il merito. In più, in un sistema non più chiuso ma globale, l'individuo di talento, tanto più quanto più il suo talento è elevato, ha una via di uscita ben chiara: andarsene all'estero e lasciare i mediocri senza nessuno da cui copiare.
Il primo e più evidente caso di mancata meritocrazia risiede nell'attuale sistema di tutela dei lavoratori, i quali sono a grandi linee divisi in tre grossi gruppi: i vecchi, che hanno diritti senza lavoro e avanzamenti di carriera a pioggia, chiusi in aziende che non possono licenziare nessuno ma che anche per questo faticano a rinnovarsi e quindi a restare competitive; i giovani che ce la fanno ad entrare nel sistema economico, i quali hanno lavoro senza diritti, sono magari ben retribuiti ma privi di garanzie, soggetti allo “straordinario obbligatorio” negli uffici per coprire la bassa produttività di troppi colleghi, e senza prospettive di lungo termine, specialmente man mano che i “piani alti” sia gestionali che tecnologici delle nostre aziende volano all'estero tramite acquisizioni o rilocalizzazioni; e infine i giovani che non ce la fanno, che non hanno nè lavoro nè diritti, chiusi se va bene in un call center a farsi sfruttare da “imprenditori” (tra virgolette) che, ottenute le commesse spesso grazie a conoscenze o direttamente alle mazzette, prendono i giovani a lavorare con contratti di un mese per volta a quattro euro lordi all'ora.
La differenza di trattamento tra i vecchi – assunti a tempo indeterminato, totalmente garantiti anche quando assenteisti o incompetenti, fino ad ottenere una pensione spesso ampiamente superiore ai contributi versati – e i giovani – precari, privi di quasi ogni forma di welfare, prime vittime di qualsiasi ristrutturazione aziendale anche quando meritevoli, e destinati a una pensione uguale o inferiore ai contributi versati – non è più giustificabile né moralmente, né socialmente, né economicamente.
Non è giustificabile che un giovane di 33 anni con quasi dieci anni di carriera e 50.000 euro di contributi versati abbia maturato, stando al sito INPS, una pensione stimata di 16,55 euro al mese; mentre suo padre sia appena andato in pensione a 58 anni con una cifra mensile superiore ai contributi versati, e pari a quattro volte lo stipendio di un giovane ricercatore di punta. Queste discrepanze alimentano la dipendenza dei giovani dai genitori fino ad età avanzata, e insieme tolgono loro la speranza e la voglia di fare, uccidendo le speranze di ripresa nel lungo termine di tutto il Paese.
Inoltre, vi è il problema di come supportare le idee di questi giovani nel momento più importante, quello in cui da mera speculazione devono trasformarsi in realtà, ossia in un progetto di ricerca applicata o in una start-up. Molto si è mosso in questi anni, ma anche qui subendo i problemi sistematici della società italiana; per esempio, gli incubatori universitari, idea in sé ottima, sono troppo spesso diventati un mostruoso incrocio tra una agenzia immobiliare per la collocazione di spazi universitari in disuso e un parcheggio per personale amministrativo in esubero. Similmente, i fondi pubblici o parapubblici per il sostegno all'imprenditoria giovanile soffrono di mali noti, dalla distribuzione a pioggia ai tempi biblici per l'erogazione, dalla spartizione politica fino al caso inquietante di venture capital finanziati dalle istituzioni locali che ogni anno spendono in stipendi e consulenze più di quanto investono.
Anche in questo caso è necessario introdurre un controllo di merito sia sulle idee che sui risultati degli strumenti destinati a supportarle; inoltre, nell'approccio italiano vi è un serio problema di commistione di ruoli tra pubblico e privato. E' certamente positivo che le Università si aprano al mercato, ma ciò non deve snaturare il loro ruolo come produttrici di ricerca collettiva e liberamente condivisa, su programmi di medio-lungo periodo, a vantaggio di tutta la società; i dipartimenti universitari non devono diventare aziende a fine di lucro in concorrenza l'una con l'altra per strapparsi dieci giornate di consulenza, magari utilizzando gli studenti come manodopera sottopagata nelle aziende personali dei docenti, né alimentare la logica della brevettazione dell'acqua calda, che per un paese tecnologicamente polverizzato e marginale come il nostro è una strategia perdente.
E' necessario invece che sia il privato a fare il mestiere del privato, quello di assumersi il rischio di finanziare start-up e spin-off su idee innovative; rischio peraltro che, se diversificato su larga scala, gestito in maniera competente, soggetto a spietate valutazioni di merito e liberato da logiche di raccomandazione, si rivela essere molto minore di quel che sembra. Va però rilevato che, dette le carenze del pubblico, anche il privato spesso non scherza. Decenni di fondi pubblici concessi sulla base di pile di carta e di giri di fatture allegre hanno instillato in troppi imprenditori italiani l'idea che la ricerca si fa solo se la paga lo Stato e solo se non interferisce con i deliverable di domani mattina, fino a quando ci si rende conto troppo tardi di essere cinque anni in ritardo sul mondo; mentre il sistema creditizio funziona molto spesso su logiche burocratiche o clientelari che scimmiottano quelle della pubblica amministrazione.
In un circolo di interazione virtuosa tra pubblico e privato, il pubblico dovrebbe farsi carico della ricerca di base, senza ansie da budget o da trimestrali di cassa, mentre il privato, magari incentivato tramite strumenti di detassazione degli investimenti, dovrebbe finanziare le giovani imprese con molta più facilità.
In tutto questo, i fondi nazionali e internazionali disponibili – a partire dal settimo Programma Quadro europeo – dovrebbero essere sfruttati meglio, grazie soprattutto ad un incremento della capacità di fare sistema, sia tra i vari nodi della rete di PMI che caratterizza l'Italia, sia con le Università e i centri di ricerca pubblica, sempre con una chiara distinzione di ruoli; e anche tramite un incremento delle opportunità di social networking, sia mediante strumenti tradizionali come gli sportelli di orientamento, sia mediante sistemi tecnologici innovativi di accoppiamento tra necessità e competenze. Anche questo tuttavia richiede un cambiamento di mentalità diffusa nell'industria italiana, passando da una visione “furbetta”, tesa a massimizzare l'incasso di fondi nel breve periodo minimizzando l'impegno, a una visione sana, conscia della necessità imprescindibile dell'innovazione nel medio-lungo periodo.
In generale, quindi, si osserva come i problemi del sistema socio-economico italiano siano spesso riconducibili ad alcuni fattori fondamentali, come la mancanza di meritocrazia, l'incapacità di ragionare a medio-lungo periodo, e in generale una crescente sfiducia nel futuro e nella propria vita professionale. Nel profondo rinnovamento morale di cui l'Italia ha bisogno, è necessario che anche l'atteggiamento verso il lavoro si modifichi, e che il lavoro ritorni ad essere non una condanna, ma un momento essenziale di gratificazione dell'individuo, con attenzione per tutti, ma con una ricompensa proporzionale all'impegno e alle capacità. Soltanto questo può motivare le giovani generazioni a dare il massimo per far ripartire l'Italia, sfruttandone il talento e la voglia di crescere, di costruire un mondo migliore e più ricco per sé e di riflesso per gli altri.
Nell'era della conoscenza, il vero capitale delle imprese è costituito dalle persone; è costituito dall'esperienza, dall'impegno, dalle idee, dall'innovazione che esse portano giorno dopo giorno. Nessuna azienda può sopravvivere senza attivare una sinergia positiva tra l'imprenditore, i lavoratori e le altre imprese della rete. In questo scenario, l'imprenditore ha il privilegio e insieme la responsabilità di creare ricchezza non solo per sé, ma anche per gli altri. La storia dell'industria italiana è piena non soltanto di furbetti, faccendieri ed evasori fiscali, ma anche di grandi imprenditori che hanno costruito le principali aziende del Paese, e con esso la sua ricchezza diffusa.
Perché questa ricchezza possa essere mantenuta ed accresciuta, è necessario che i nuovi imprenditori e le nuove idee possano emergere, negli unici settori dove ciò è possibile in un paese sviluppato – quelli ad alta intensità di conoscenza. Per questo è fondamentale che la tutela e la promozione dei giovani lavoratori della conoscenza diventi un obiettivo centrale della politica economica di questo Paese.
Ne consegue che le speranze di crescita di un paese come l'Italia sono fortemente legate a una specifica categoria sociale: quella dei giovani lavoratori della conoscenza. Giovani, perché l'innovazione – non solo quella evolutiva, ma soprattutto quella rivoluzionaria, dalle maggiori potenzialità di impatto sul mercato – dipende dalla capacità di pensare fuori dagli schemi e dalla disponibilità al rischio personale, due caratteristiche che mediamente diminuiscono con l'età; della conoscenza, perché in molti settori – dall'informatica ai servizi passando per la comunicazione – l'innovazione dipende ormai poco, almeno nelle fasi iniziali, dalla disponibilità di capitali, e molto di più dall'avere un'idea al passo con l'evoluzione del mercato globale, e dalla capacità di declinarla in una rete di relazioni su scala planetaria. E inoltre, lavoratori, nel senso che le imprese innovative devono correre più delle altre, né hanno rendite di posizione su cui contare per mantenersi; per cui la quantità di lavoro è garantita.
I giovani lavoratori della conoscenza sono una categoria molto ampia, ma possono essere ricondotti ad alcune tipologie principali. Molti sono tecnici, che lavorano per aziende private spesso di dimensione medio-piccola, con un rapporto dipendente nei fatti, ma precario nella forma. Alcuni sono ricercatori universitari, solitamente costretti a vivere di stenti e sovvenzioni paterne fino all'arrivo di una raccomandazione che gli permetta di ottenere un impiego pubblico. Infine vi è un numero crescente di schegge impazzite, professionisti che vivono di consulenze oppure mettono in piedi piccole imprese altamente specializzate.
Lavorare con la conoscenza è per molti versi un privilegio: la fatica fisica è ridotta, il piacere intellettuale è elevato, la noia è rara e si può godere in molti casi di una inebriante sensazione di libertà, che spesso coincide con l'assenza di orari e di vincoli, a parte le scadenze concordate con i clienti. Si lavora comunque parecchio, ma si sa che la ricompensa per il proprio lavoro, se ben fatto, non sarà intascata da nessun altro (a parte quel 60% che si prende lo Stato, ovviamente). In più, si gode di una vista privilegiata su molti fenomeni socioeconomici; alcuni individui giungono persino in posizioni dove possono influenzarli, tramite quegli eventi a valanga per cui un ventenne californiano inventa Napster per gioco e dieci anni dopo la multimiliardaria industria della musica è alla frutta, oppure per cui un paio di ragazzi fanno una tesi di laurea su un motore di ricerca, ci credono, trovano terreno fertile e meno di dieci anni dopo Google capitalizza centocinquanta miliardi di dollari.
Questi esempi mettono in evidenza come il paradigma stesso dell'economia sia, almeno nei settori con forte potenzialità di crescita, drammaticamente cambiato. Grazie alla globalizzazione e all'impatto profondo della rete globale, molti muri invisibili sono crollati; quello tra lavoro e tempo libero, quello tra imprenditore e dipendente, e persino quello tra politica ed economia, con i governi sempre più impotenti a dirigere le proprie società di fronte a logiche economiche internazionali. Una persona che è dipendente di una Università, ma che deve costantemente inventarsi nuovi progetti e nuovi stimoli per reperire fondi e dare un senso al proprio lavoro, è più un dipendente o più un imprenditore? E una persona che è contemporaneamente socio di una piccola impresa, libero professionista, consulente per grandi aziende, manager a gettone, può essere classificata?
Proprio per la sua crucialità, la categoria dei giovani lavoratori della conoscenza viene coltivata e coccolata in molte nazioni, anche con politiche di attrazione di talenti dall'estero. In Italia, invece, sono dolori: nel nostro Paese la classe dirigente ha ancora in testa il modello industriale del dopoguerra, in cui o si è lavoratore, o si è padrone, o al massimo si è professionista dentro un ordine riconosciuto; non è quindi che l'Italia disprezzi questo tipo di lavoratori, semplicemente non li concepisce. Di conseguenza, proprio una categoria così cruciale è completamente abbandonata dal sistema di welfare del Paese; è inquadrata dal fisco come lavoratore autonomo (quindi per definizione presunto evasore fiscale), pagando tasse e contributi elevati, per i quali però non riceve alcun servizio o tutela, perché non ricade in alcuna delle categorie sindacali e solitamente nemmeno in alcuna di quelle professionali o padronali.
In un paese diviso per caste, questi lavoratori sono i paria: magari con un lavoro gratificante e talvolta anche ben remunerati, ma privi di sicurezze ed esclusi da qualsiasi forma di assistenza e di rappresentanza politica e sociale.
Di conseguenza, in Italia questi lavoratori difficilmente sopravvivono; o si adeguano al sistema, perdendo presto le aspirazioni ad un lavoro innovativo per inserirsi in binari di carriera più consolidati ma anche molto meno utili per il Paese, o emigrano. Infatti, a velocità sempre più sconvolgente, negli ultimi vent'anni si è visto lo schema dell'emigrazione italiana cambiare drammaticamente: non una emigrazione – come è sempre stata – di lavoratori poco qualificati, tradizionalisti e semi-analfabeti, verso territori a maggior crescita; ma una emigrazione dei migliori talenti, degli innovatori e degli intraprendenti, verso territori dove ci sia maggior possibilità di crescere e di essere riconosciuti. Questo è il pattern di emigrazione tipico delle nazioni africane, e questo cambiamento da solo dovrebbe essere un segnale estremamente preoccupante; se non fosse che la nostra politica non se ne è nemmeno accorta, come dimostra il clamoroso errore di stima di Berlusconi sull'identikit e quindi sul voto degli italiani all'estero alle ultime elezioni.
A chi sia interessato a rilanciare lo sviluppo economico e sociale dell'Italia, si pone quindi come problema urgente quello di creare le condizioni perlomeno per trattenere i nostri migliori talenti, e magari per cominciare ad attrarre quelli degli altri. Purtroppo però tali condizioni richiedono modifiche radicali della mentalità degli italiani; una rivoluzione sociale per la quale forse, nell'attuale clima di sfascio, esistono le premesse, ma che è certamente molto difficile da realizzare.
Per prima cosa, è necessario mettere al centro di ogni dinamica sociale la meritocrazia. In un sistema chiuso, può succedere che tre studenti poco capaci sequestrino lo studente migliore nel bagno della scuola e lo torturino fino a convincerlo a fare i compiti anche per loro, in mezzo agli applausi di tutta la classe (è successo pochi giorni fa vicino a Grosseto). La stessa cosa è sempre successa sul lavoro; in molte aziende, il lavoratore migliore viene mobbato dai colleghi perché lavori di meno e non metta troppo in evidenza la pigrizia o la mediocrità altrui. Quando anche ciò non succede, di solito in Italia le politiche retributive e di carriera sono prevalentemente slegate dal merito, e basate teoricamente su una equità formale che premia i peggiori, e di fatto su raccomandazioni e parentele.
Al di là di qualsiasi considerazione etica, è evidente che un sistema di selezione sociale di questo tipo provoca un appiattimento verso il basso, e quindi rende le aziende italiane non competitive rispetto alle altre società nazionali che premiano il merito. In più, in un sistema non più chiuso ma globale, l'individuo di talento, tanto più quanto più il suo talento è elevato, ha una via di uscita ben chiara: andarsene all'estero e lasciare i mediocri senza nessuno da cui copiare.
Il primo e più evidente caso di mancata meritocrazia risiede nell'attuale sistema di tutela dei lavoratori, i quali sono a grandi linee divisi in tre grossi gruppi: i vecchi, che hanno diritti senza lavoro e avanzamenti di carriera a pioggia, chiusi in aziende che non possono licenziare nessuno ma che anche per questo faticano a rinnovarsi e quindi a restare competitive; i giovani che ce la fanno ad entrare nel sistema economico, i quali hanno lavoro senza diritti, sono magari ben retribuiti ma privi di garanzie, soggetti allo “straordinario obbligatorio” negli uffici per coprire la bassa produttività di troppi colleghi, e senza prospettive di lungo termine, specialmente man mano che i “piani alti” sia gestionali che tecnologici delle nostre aziende volano all'estero tramite acquisizioni o rilocalizzazioni; e infine i giovani che non ce la fanno, che non hanno nè lavoro nè diritti, chiusi se va bene in un call center a farsi sfruttare da “imprenditori” (tra virgolette) che, ottenute le commesse spesso grazie a conoscenze o direttamente alle mazzette, prendono i giovani a lavorare con contratti di un mese per volta a quattro euro lordi all'ora.
La differenza di trattamento tra i vecchi – assunti a tempo indeterminato, totalmente garantiti anche quando assenteisti o incompetenti, fino ad ottenere una pensione spesso ampiamente superiore ai contributi versati – e i giovani – precari, privi di quasi ogni forma di welfare, prime vittime di qualsiasi ristrutturazione aziendale anche quando meritevoli, e destinati a una pensione uguale o inferiore ai contributi versati – non è più giustificabile né moralmente, né socialmente, né economicamente.
Non è giustificabile che un giovane di 33 anni con quasi dieci anni di carriera e 50.000 euro di contributi versati abbia maturato, stando al sito INPS, una pensione stimata di 16,55 euro al mese; mentre suo padre sia appena andato in pensione a 58 anni con una cifra mensile superiore ai contributi versati, e pari a quattro volte lo stipendio di un giovane ricercatore di punta. Queste discrepanze alimentano la dipendenza dei giovani dai genitori fino ad età avanzata, e insieme tolgono loro la speranza e la voglia di fare, uccidendo le speranze di ripresa nel lungo termine di tutto il Paese.
Inoltre, vi è il problema di come supportare le idee di questi giovani nel momento più importante, quello in cui da mera speculazione devono trasformarsi in realtà, ossia in un progetto di ricerca applicata o in una start-up. Molto si è mosso in questi anni, ma anche qui subendo i problemi sistematici della società italiana; per esempio, gli incubatori universitari, idea in sé ottima, sono troppo spesso diventati un mostruoso incrocio tra una agenzia immobiliare per la collocazione di spazi universitari in disuso e un parcheggio per personale amministrativo in esubero. Similmente, i fondi pubblici o parapubblici per il sostegno all'imprenditoria giovanile soffrono di mali noti, dalla distribuzione a pioggia ai tempi biblici per l'erogazione, dalla spartizione politica fino al caso inquietante di venture capital finanziati dalle istituzioni locali che ogni anno spendono in stipendi e consulenze più di quanto investono.
Anche in questo caso è necessario introdurre un controllo di merito sia sulle idee che sui risultati degli strumenti destinati a supportarle; inoltre, nell'approccio italiano vi è un serio problema di commistione di ruoli tra pubblico e privato. E' certamente positivo che le Università si aprano al mercato, ma ciò non deve snaturare il loro ruolo come produttrici di ricerca collettiva e liberamente condivisa, su programmi di medio-lungo periodo, a vantaggio di tutta la società; i dipartimenti universitari non devono diventare aziende a fine di lucro in concorrenza l'una con l'altra per strapparsi dieci giornate di consulenza, magari utilizzando gli studenti come manodopera sottopagata nelle aziende personali dei docenti, né alimentare la logica della brevettazione dell'acqua calda, che per un paese tecnologicamente polverizzato e marginale come il nostro è una strategia perdente.
E' necessario invece che sia il privato a fare il mestiere del privato, quello di assumersi il rischio di finanziare start-up e spin-off su idee innovative; rischio peraltro che, se diversificato su larga scala, gestito in maniera competente, soggetto a spietate valutazioni di merito e liberato da logiche di raccomandazione, si rivela essere molto minore di quel che sembra. Va però rilevato che, dette le carenze del pubblico, anche il privato spesso non scherza. Decenni di fondi pubblici concessi sulla base di pile di carta e di giri di fatture allegre hanno instillato in troppi imprenditori italiani l'idea che la ricerca si fa solo se la paga lo Stato e solo se non interferisce con i deliverable di domani mattina, fino a quando ci si rende conto troppo tardi di essere cinque anni in ritardo sul mondo; mentre il sistema creditizio funziona molto spesso su logiche burocratiche o clientelari che scimmiottano quelle della pubblica amministrazione.
In un circolo di interazione virtuosa tra pubblico e privato, il pubblico dovrebbe farsi carico della ricerca di base, senza ansie da budget o da trimestrali di cassa, mentre il privato, magari incentivato tramite strumenti di detassazione degli investimenti, dovrebbe finanziare le giovani imprese con molta più facilità.
In tutto questo, i fondi nazionali e internazionali disponibili – a partire dal settimo Programma Quadro europeo – dovrebbero essere sfruttati meglio, grazie soprattutto ad un incremento della capacità di fare sistema, sia tra i vari nodi della rete di PMI che caratterizza l'Italia, sia con le Università e i centri di ricerca pubblica, sempre con una chiara distinzione di ruoli; e anche tramite un incremento delle opportunità di social networking, sia mediante strumenti tradizionali come gli sportelli di orientamento, sia mediante sistemi tecnologici innovativi di accoppiamento tra necessità e competenze. Anche questo tuttavia richiede un cambiamento di mentalità diffusa nell'industria italiana, passando da una visione “furbetta”, tesa a massimizzare l'incasso di fondi nel breve periodo minimizzando l'impegno, a una visione sana, conscia della necessità imprescindibile dell'innovazione nel medio-lungo periodo.
In generale, quindi, si osserva come i problemi del sistema socio-economico italiano siano spesso riconducibili ad alcuni fattori fondamentali, come la mancanza di meritocrazia, l'incapacità di ragionare a medio-lungo periodo, e in generale una crescente sfiducia nel futuro e nella propria vita professionale. Nel profondo rinnovamento morale di cui l'Italia ha bisogno, è necessario che anche l'atteggiamento verso il lavoro si modifichi, e che il lavoro ritorni ad essere non una condanna, ma un momento essenziale di gratificazione dell'individuo, con attenzione per tutti, ma con una ricompensa proporzionale all'impegno e alle capacità. Soltanto questo può motivare le giovani generazioni a dare il massimo per far ripartire l'Italia, sfruttandone il talento e la voglia di crescere, di costruire un mondo migliore e più ricco per sé e di riflesso per gli altri.
Nell'era della conoscenza, il vero capitale delle imprese è costituito dalle persone; è costituito dall'esperienza, dall'impegno, dalle idee, dall'innovazione che esse portano giorno dopo giorno. Nessuna azienda può sopravvivere senza attivare una sinergia positiva tra l'imprenditore, i lavoratori e le altre imprese della rete. In questo scenario, l'imprenditore ha il privilegio e insieme la responsabilità di creare ricchezza non solo per sé, ma anche per gli altri. La storia dell'industria italiana è piena non soltanto di furbetti, faccendieri ed evasori fiscali, ma anche di grandi imprenditori che hanno costruito le principali aziende del Paese, e con esso la sua ricchezza diffusa.
Perché questa ricchezza possa essere mantenuta ed accresciuta, è necessario che i nuovi imprenditori e le nuove idee possano emergere, negli unici settori dove ciò è possibile in un paese sviluppato – quelli ad alta intensità di conoscenza. Per questo è fondamentale che la tutela e la promozione dei giovani lavoratori della conoscenza diventi un obiettivo centrale della politica economica di questo Paese.