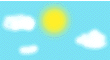Ieri sera mi sono un po’ rappacificato con Il Cairo: infatti, dopo aver trascorso praticamente tutto il giorno in camera a lavorare a varie cose, avevo voglia di uscire e ho combinato la serata con Roberto Gaetano e famiglia. Io e Roberto frequentiamo ICANN insieme ormai da sei anni, e abbiamo una lunga storia di riunioni e ristoranti in giro per il mondo; peraltro la prima volta che ci incontrammo in Italia fu al meeting ICANN di Roma 2004, ma prima di allora ci eravamo gi√† incontrati in mezzo mondo, nell’ordine prendendo un orrido panino pieno di salse in un bar fighetto di Marina del Rey (Los Angeles, 2000), incontrandoci per completo caso all’uscita di un pub ristorante a Dublino (estate 2001) e poi ancora a Montevideo, Bucarest, Amsterdam, Rio de Janeiro, insomma ovunque ma non in Italia.
Lui, comunque, aveva l√¨ una voglia di ristorante Falfela in centro al Cairo, rimasta dal meeting ICANN del 2000, e cos√¨ ci siamo fatti chiamare una macchina dall’albergo e siamo andati l√¨. Il posto √® carino, abbastanza tipico, anche se pieno di turisti; ti guardano comunque male, e persiste quella sensazione di non essere poi cos√¨ benvenuti da queste parti, per√≤ il cibo era buono e abbiamo speso una cifra umana, tipo 13 euro a testa, contro i 40 abbondanti di cui ti pelano i ristoranti dell’albergo. Oggi a pranzo con la stessa cifra ho preso un panino e una coca cola!
Soprattutto, ciò che mi ha riconciliato con questa città è stato il giro a piedi per il centro Рo meglio, per la parte mondana del centro, la zona novecentesca costruita in stile europeo-newyorchese Рdopo cena, a notte avanzata. Quello stesso centro che visto di giorno è squallido e cadente la sera si trasforma in un magico fiume di luci: ci sono insegne ovunque, in latino e in arabo, di ogni colore.
Capisci cos√¨ che Cairo √® la New York del mondo arabo: l’unica vera metropoli del Medio Oriente (tenendone fuori la Turchia). Non che le abbia viste tutte, ma vi garantisco che Tunisi o Marrakech sono completamente diverse, perch√© non hanno questa dimensione; qui vivono venticinque milioni di persone, e lo si percepisce. In realt√† vi sono molti centri, e mi √® anche venuta voglia di scoprire come sono di notte i vicoletti del Cairo islamico e della zona della Cittadella (non temete, non la soddisfer√≤). Ma anche solo il centro basso √® affascinante: in mezzo a questo fiume di luce vi sono in giro migliaia di persone, che escono ed entrano da locali e caff√©. Ci sono negozi di ogni tipo, e si pu√≤ trovare in fila, spesso ancora aperti, un forno dove un bimbo guarda estasiato un enorme vassoio di biscotti; un venditore di meraviglioso antiquariato in stile orientale; un buco lurido dove riparano motociclette; l’ingresso di un vicolo misterioso che porta in casa di qualcuno, o forse a uno dei tanti mercatini.
Certo, i marciapiedi sono sconnessi e pieni di auto in ogni dove, e a ciascun attraversamento si rischia il game over: credo di aver gi√† scritto l’altra volta che Cairo √® un enorme Frogger dal vivo, dove ordinariamente le auto e persino i camion ti sfrecciano a cinque centimetri dalla faccia mentre attraversi, calcolando dinamicamente la tua e la loro posizione, indipendentemente dal colore del semaforo, dai segnali e dalle precedenze. Esitare √® fatale, in senso assolutamente stretto: quando parti, vai e prega.
Per√≤, girando a caso per il centro del Cairo, si scoprono angoli di vero mistero; e si finisce per esempio addentro a una lunga fila di taxi che occupa la strada, in coda per fare benzina (24 eurocent al litro) all’unico distributore; oppure in un mercato notturno pieno di gente che compra, dove una parete √® occupata da scatole sbugnate e scrostate di monitor LCD da computer, mentre dall’altra un nuovissimo negozio di lampadari sfoggia delle composizioni vetrarie che sembrerebbero barocche e pesanti persino a uno spagnolo.
Certo, quando ti accorgi che √® tardi e devi tornare indietro, ti rendi conto che non sai dove sei e che nessuno ha una cartina; ma non importa. Basta camminare un po’ per il mercato, fino a uno spiazzo dove due dei classici taxi bianchi e neri, tenuti insieme dallo scotch, aspettano clienti; il primo tassista non parla altro che dialetto cairota, ma va ad abbrancare il giovanotto che fa da interprete. Citystars – il nome del nuovissimo, periferico complesso dove stiamo noi; e periferico vuol dire una ventina di chilometri di case ininterrotte – √® la parola d’ordine; il tassista non √® sicuro di aver capito, ma il giovanotto lo istruisce. E cos√¨, per quasi un’ora giriamo a caso nella periferia nord del Cairo, pigiati in cinque in una 127 bianconera, in mezzo a dedali di vie e sopraelevate e svolte obbligate, pregando che lui trovi alfine una strada.
Muoversi per l’immensa periferia del Cairo √® complicato; i grumi di case sulle colline e sulle dune sono intercalati da enormi vialoni da sei corsie per senso di marcia, sui quali invece che a Frogger si gioca a Out Run. Si inchioda per arretrare e passare dall’altro lato il camion che sta sterzando a destra costringendo a frenare altre due auto che nel frattempo accostano verso un pedone che deve salire evitando l’albero di palme e il tombino rotto con un palo di ferro arrugginito piantato dentro, nel bel mezzo della carreggiata, a dire “qui non si passa”. Abbiamo anche fatto il livello del tunnel: un buco a due corsie lungo quasi quattro chilometri, dal percorso a serpentina, con auto che si sorpassano da entrambe le parti e moto che sorpassano in mezzo, nessun tipo di ventilazione forzata, e una atmosfera gassosa che implica morte certa per asfissia nel caso in cui ti si fermi la macchina l√¨ sotto.
E poi c’√® il livello tortuoso: infatti i vialoni non hanno incroci perch√© sarebbero troppo pericolosi, n√© semafori perch√© tanto sarebbero inutili. Se due vie si incrociano e non si pu√≤ fare un mega-raccordo cementizio, la soluzione √® che una delle due vie si scontri con lo spartitraffico dell’altra; quindi chi arriva di l√¨ √® costretto a girare a destra, andare avanti per qualche centinaio di metri, poi in mezzo c’√® un buco nello spartitraffico che permette una inversione a U, in modo da tornare indietro e poi risvoltare nel proseguimento della via. Insomma, una rotonda schiacciata!
Notevole anche quando la passeggera alla mia sinistra voleva aprire il finestrino: il tassista, mentre con una mano tiene la sigaretta, con l’altra tiene il cellulare e con la terza tiene il volante, con la quarta mano estrae da sopra il parasole la manovella mancante, che infila a forza, girandosi per met√†, nel buco del finestrino posteriore sinistro, girando per aprirlo mentre slalomeggia tra le auto per strada e scarica la cenere sull’asfalto.
A un certo punto abbiamo passato senza danno persino il difficilissimo livello “attraversamento dell’autostrada”, in cui due gruppi di pedoni, invisibili nel buio della notte, attraversano le sei corsie del vialone a distanza di esattamente un metro e ottanta l’uno dall’altro, e il tuo tassista lanciato a oltre cento all’ora ci si infila in mezzo, dieci centimetri dal culo dei primi e dieci dalla faccia dei secondi, mentre questi continuano a camminare a velocit√† regolare, e senza nemmeno rallentare un briciolo la corsa del veicolo. L√¨ √® scoppiato spontaneo l’applauso!
Ma il vero momento magico √® stato quando, trovata la strada principale sbarrata, il nostro autista ci ha portati in mezzo a una intera citt√† abbandonata: centinaia di metri di casupole a uno o due piani, eleganti e decorate, apparentemente risalenti a secoli fa, completamente vuote e abbandonate. A un certo punto c’era persino quello che sembrava un caravanserraglio, anch’esso abbandonato; si stagliava contro il cielo illuminato dalla luna e faceva davvero un grande effetto.
E’ stata solo una visione di pochi secondi, presto sottrattaci da un nuovo livello di Out Run; ma √® stata sufficiente a farmi pensare che il Cairo abbia dentro di s√© molto pi√Ļ di quel che potrebbe sembrare a prima vista.
[tags]cairo, taxi, traffico, egitto, viaggi, icann[/tags]