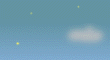Come tutti, anch’io ho passioni segrete di cui mi vergogno; per questo, ora farò qualcosa di coraggioso. Vi svelerò il motivo per cui ho preso il mio bel treno regionale a carbonella (al ritorno, sostituito da autobus) e sono andato a Milano in un sabato piovoso: è per assistere a Indieverse.
Che cos’è Indieverse? Lo dice il banner sul sito: “L’evento GRATUITO Che Segna Il Punto Di Svolta Per Il Self-Publishing Italiano”, grosso e maiuscolato come se non ci fosse un domani. È la nuova creatura di Rotte Narrative, una delle scuole di scrittura commerciale che più imperversano sui social, di cui non sono mai stato cliente ma che seguo ogni tanto.
Badate, l’aggettivo commerciale non è in sé negativo: semplicemente, ci si concentra su come produrre e vendere libri che possano piacere a un pubblico ampio e definito, cosa diversa dallo scrivere per esprimere se stessi o per piacere ai critici o per ambizione letteraria. La questione, però, è che nell’editoria di oggi la scrittura commerciale è tutto ciò che c’è; per il resto, probabilmente si può provare tramite scuole di altro taglio – per dire, mi piacerebbe una volta fare il laboratorio di Giulio Mozzi, anche se per ora è incompatibile con la mia vita lavorativa – ma le opportunità , in un mercato ormai ai minimi termini, sono davvero ridotte.
Insomma, praticamente nessun editore, grande o piccolo, nuovo o antico, sconosciuto o prestigioso, scommetterà su un libro che non è già a priori costruito per vendere (a meno che non lo paghi l’autore). E questo vuol dire algoritmo: vuol dire pianificare e rivendicare da subito l’appartenenza a un genere preciso con una copertina precisa e dei tropi precisi, vuol dire ripetere più o meno sempre la stessa storia, lo stesso andamento, lo stesso ciclo dell’eroe con gli stessi personaggi, soltanto nascosti sotto un “high concept” diverso (tipo, per i manga, “sono morto e mi sono reincarnato in una lavatrice”). E quindi, vai di depliant viola intitolati “La formula del batticuore”, perché mai, mai deviare dalla formula.
Ora, Indieverse ha uno scopo concreto: incoraggiare la massa di aspiranti, quella che segue le formule ma comunque non trova un editore, a passare all’autopubblicazione su Amazon. Infatti, il prestigioso auditorium in centrissimo a Milano e tutto il resto della giornata sono sponsorizzati da loro e da altri fornitori di servizi mirati.
Io, peraltro, sono uno della massa; sono qui per imparare e magari trovare contatti utili. Arrivo, faccio la fila alla registrazione, saccheggio tutti i gadget possibili e immaginabili, offerte sconto sui corsi, depliant, pubblicità . I libri tipo “Da zero a stile in quattro settimane” però si pagano, quindi non li prendo.
Entro nella sala, mi siedo, aspetto, mi viene voglia di scrivere… questo post. Così apro il portatile e le dita. Alla fine, un quarto d’ora dopo l’ora prevista, il capo della scuola sale sul palco e annuncia che si inizierà tra un paio di minuti, perché “vedo che stanno ancora scendendo gente”. Va bene, anch’io quando parlo mi inciampo. Però, lui è molto bravo a rapportarsi con la folla, fa battute, ci sa fare. Si fa il classico selfie con la sala piena alle spalle.
Mi guardo attorno: il pubblico è molto più di mezz’età di quel che avrei detto. Se mai, i giovani sono sul palco, sono quelli che si muovono con successo tra autopromozione social a trentadue denti e guerrilla marketing su Amazon, mentre, come me, i vecchi postelegrafonici col romanzo nel cassetto stanno ancora elaborando il lutto per l’imminente estinzione del modello tradizionale di editore. Però, c’è comunque anche una nutrita presenza di trentenni, più donne che uomini.
L’intervento inizia, e anche se ovviamente contiene una sfilza di informazioni logistiche, di ringraziamenti agli sponsor e di retorica di persuasione, la parte sul mercato editoriale è molto centrata; andrebbe registrata e mostrata in giro. Parla di come il libro sia inestricabilmente sia opera d’arte che prodotto, e che trascurare per snobismo la seconda parte non abbia senso, e sia forse anche una delle cause della disaffezione generale alla lettura. Parla anche di come non abbia senso rimanere con la testa al ventesimo secolo, di come la rete sia fonte di grandi opportunità . Ed è vero, e sotto sotto mi chiedo perché proprio io, che venticinque anni fa facevo startup di musica digitale, sia ancora mentalmente portato ad aspettare il libro di carta e l’editore paludato: devo essere vecchio.
Esco mentre salgono sul palco le signore di uno sponsor, ossia la FUIS, Federazione Unitaria Italiana Scrittori. Sembra un sindacato e lo è: nasce dalla fusione dei sindacati degli scrittori di CGIL, CISL e UIL (sì, esistevano). Io faccio il giro dell’isolato per raggiungere i workshop, che sono in piazza San Fedele (“davanti al Manzoni”) e solo su prenotazione.
Nei workshop, tenuti da editor professionisti, si creano subito buone vibrazioni. Non c’è quasi nulla che non sapessi già , ma il riassuntone iniziale sull’autore-imprenditore, su canali e strategie per costruire un brand autoriale e arrivare positivamente sul mercato, dovrebbe essere spiegato a chiunque voglia scrivere qualcosa oggi e non abbia un cugino che lavora per un primario editore, e anche a chi ce l’ha (ops).
In sala, tra compagni di sventura, ci si conosce e ci si confronta (conforta) a vicenda. La sala si riempie di domande, alcune ingenue, altre invece dritte al punto. Una signora chiede se a forza di ingegnerizzare pubblici e algoritmi non si finisca per uccidere il talento e produrre libri sempre tutti uguali, e tutta la sala sospira di empatia (comunque la risposta classica delle scuole di scrittura moderne è che il talento non esiste e non serve, contano studio, tecnica, determinazione e mentalità imprenditoriale).
Abbranco la povera editor di Acheron nonché autrice di romantasy, senza più voce dopo un’ora di assalto collettivo, e le dico: io scrivo una roba che sta all’incrocio tra fantasy, shonen manga e light novel, ci sono editori, editor, agenzie, canali specializzati nel mio genere? Lei risponde “eeeh” e mi fa gli auguri.
Pausa pranzo ovviamente da Luini, bibita in un Carrefour Market in un’elegante galleria meneghina che puzza di piscio e barboni, e ritorno in sala. Prima di iniziare, un altro aspirante davanti a me chiacchiera e dice che a lui in fondo fare anche marketing piace, tanto che sui social segue Frank Merenda; ma sa un po’ di sindrome di Stoccolma.
Il pomeriggio inizia con una gentile signora che spiega come il Salone del Libro abbia deciso di dare uno spazio agli autori self, ma abbia dovuto introdurre una quota di partecipazione e una selezione sulla qualità editoriale, perché arrivavano una montagna di schifezze; e però, ora funziona.
Passo al workshop con un autore e editor di fantasy e giochi: l’esperienza mi rincuora, perché più o meno, nel tempo, sono già arrivato da solo a tutti i suggerimenti che dà . Alla fine chiedo anche a lui qualche contatto, mi dà un paio di nomi, ma aggiunge: però i professionisti costano.
È vero, è ovvio, ed è il problema di fondo del mercato del self: proprio perché lo si vuole impostare come attività professionale, ha senso investire mille o duemila euro di editor, illustratore e pubblicità per un romanzo che nel 99% dei casi ne incasserà forse duecento? Con questo dubbio in testa, lascio perdere la premiazione dei vincitori del premio Amazon per i migliori romanzi autopubblicati del 2025 e vado a riprendere il mio treno.
Allora, grande occasione o tempo buttato? La risposta non può che essere “dipende”. Per me, forse, nessuna delle due: ma è stata sicuramente una giornata utile, come reality check, come collezione organica di indicazioni da tenere a mente e come stimolo a un esame di coscienza.
Alla fine, su una cosa concordo totalmente con gli organizzatori: l’auto-editoria non è un ripiego per chi viene scartato dagli editori. È e sarà sempre di più un canale importante, che remunera gli autori molto meglio in caso di successo e che concede loro la libertà creativa che gli editori non danno, a prezzo di un impegno di energie, di soldi, di tempo ben superiore, e rischi totali.
Quanto a me, dopo quattro anni di tentativi e nonostante quel che io percepisco come un bel percorso d’apprendimento (e un premio letterario vinto al primo tentativo), la realtà mi porterebbe a concludere che faccio cagare: scrivo male e/o le mie storie non sono interessanti. Certamente non rispettano più di tanto l’algoritmo, il target, i luoghi comuni del genere, anche se sono molto meno ingenue e incompetenti di quando ho cominciato a lavorarci per pura passione.
Però sono le mie storie, e tutte le volte che cerco di ucciderle tornano su, e mi chiedono se non possano proprio avvincere anche qualcun altro. Per questo, credo che alla fine le autopubblicherò davvero, fuori da ogni regola e speranza: le varerò con una goffaggine da Serbelloni Mazzanti e le affiderò al mare.
Forse, invece, non lo farò mai.