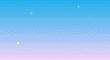I negri
Per concludere i miei racconti dall’Africa, vorrei sintetizzare (per quanto mi √® possibile: quindi solo quattro o cinque pagine) quanto in pochi giorni ho appreso dei negri, osservandoli, parlando con loro e parlando con chi vive l√† da tempo. Naturalmente √® possibile che si tratti di impressioni sbagliate, ma prima di metterle gi√Ļ mi sono premurato di chiedere e trovare conferme.
I negri condividono volentieri la miseria. Anche se muore di fame, il negro trova normale condividere con un altro negro il pezzo di cibo che ha in mano, anche se è uno che non ha mai incontrato. Per strada è tutto un fiorire di amicizie e pacche sulle spalle, e tutti si sorridono e si danno una mano. Per un negro, niente è mai veramente un problema: tutto è risolvibile chiedendo una mano a chi passa di lì in quel momento. Tuttavia, i negri condividono meno volentieri la ricchezza e il potere: date il potere in mano a un negro e nel novanta per cento dei casi sterminerà piuttosto che lasciarlo. Per ulteriori informazioni citofonare Mugabe.
I negri, pur essendo molto pi√Ļ amichevoli e simpatici dei bianchi, non hanno la minima idea di cosa sia la buona educazione. Quelli dell’appartamento di fronte piazzano lo stereo a un volume talmente forte da far sembrare i tamarri italiani dei dilettanti. Quelli dell’appartamento di sopra, a qualsiasi ora, strascinano le sedie sui bei palchetti ereditati dai portoghesi, devastandoli. Sollevare le sedie √® gi√† troppo faticoso.
I negri sono estremamente puliti. Anche se vivono in una casupola nel nulla, non hanno l’acqua in casa e possiedono in tutto tre magliette, quelle tre magliette sono sempre lavate e spesso persino stirate. I negri sono molto attenti alla propria immagine, e se appena possono hanno i jeans alla moda e le t-shirt con le scritte in inglese, all’occidentale; magari sono tarocche, ma le hanno. Aggiungeteci il fatto che sono fisicamente molto ma molto pi√Ļ belli dei bianchi, e capirete il loro giusto orgoglio di s√©. E s√¨: come testimonia anche Caparezza, hanno il pisello grande.
I negri sono generalmente pigri. Non capiscono perch√© i bianchi si rovinino la vita lavorando, pur avendo molti meno problemi di loro a mettere insieme il pranzo con la cena. Non √® che non aspirino a una condizione migliore, ma la loro valutazione di costi e benefici tende a ingigantire i costi rispetto alla nostra, almeno quando sia richiesto uno sforzo di qualsiasi genere. Noi, grazie a secoli di prediche ereditate da Calvino e Lutero, veniamo educati a considerare normale l’alzarci tutti i giorni alle sette per uscire di casa, viaggiare in mezzo al traffico e andare a lavorare; loro non lo distinguono dalla schiavit√Ļ. In effetti, ho provato ad elencare le differenze sostanziali tra le due situazioni, ma non sono sicuro di averle trovate.
I negri, proprio perch√© sono pigri, sono anche furbi. Ma non furbissimi; diciamo la furbizia di un bambino di dieci anni che pensa di far fessi i genitori. Per dire, √® praticamente impossibile per un bianco trovarsi in giro all’ora di pranzo o di cena senza che un collega, allievo o conoscente negro lo placchi e con una scusa qualsiasi non gli si stacchi pi√Ļ di dosso fino a che il bianco non si trovi sotto casa sua; a quel punto l’invito a condividere il desco √® doveroso. (Come detto prima, varrebbe la stessa cosa anche a ruoli opposti, e il negro vi darebbe con generosit√† ci√≤ che ha; non essendo stupidi, per√≤, sia il negro che il bianco preferiscono attuare la condivisione del cibo nella casa del bianco.) Se non √® ora di pranzo, comunque il negro con una scusa o con l’altra finisce sempre per entrare in cucina e farsi offrire qualcosa. Va anche bene cos√¨, visto che i negri a Maputo non muoiono di fame ma certo non ingrassano; √® un po’ stressante per il coinquilino che sta a casa e prepara il pasto, ma presto i bianchi imparano a buttare sempre la pasta molto abbondante, che qualcuno che la mangia salta sempre fuori.
I negri sono onesti, molto di pi√Ļ di quel che crediamo noi. Certo, in Mozambico i frigoriferi hanno tutti una serratura sulla porta, ma si tratta pi√Ļ della diffidenza degli europei che di una necessit√† effettiva; un vero negro difficilmente ruberebbe anche solo una scatola di biscotti, e se lo fa √® perch√© √® stato educato dagli italiani. Allo stesso tempo, la loro naturale attitudine alla condivisione li rende variamente disonesti secondo i nostri canoni (ma non secondo i loro). Per esempio, i negri chiedono continuamente soldi in prestito ai bianchi, e non li restituiscono quasi mai: l’idea √® che se tu glieli dai √® perch√© non ne hai veramente bisogno. Non solo, ma non sono nemmeno riconoscenti per il prestito: anzi, pi√Ļ gli dai soldi a babbo morto e pi√Ļ ritorneranno a chiedertene, e si offenderanno – talvolta persino incazzandosi e giurandoti vendetta – se a un certo punto smetterai di dargliene. Se ci pensate, questo √® perfettamente logico, se si parte dall’assunto che tu continui a non avere bisogno di quei soldi.
I negri sono semplici e ingenui. Non riescono a pianificare pi√Ļ di una o due cose per volta; la complessit√† li mette in crisi. Il futuro √® una entit√† sconosciuta a cui si penser√† “poi”; √® gi√† tanto se si ricordano cosa devono fare domani, e spesso cambiano idea in merito ogni dieci minuti. Le istituzioni (universit√†, ospedali, ministeri) riescono a fare piani addirittura fino a una settimana, anche se √® probabile che il giorno prima si scopra che manca, che so, l’aula, o il professore, o gli studenti, o che il giorno deputato al seminario la met√† di essi non ci siano.
I negri, se non sanno fare qualcosa, o dopo l’ennesimo errore, si mettono tranquillamente a piangere davanti a tutti. Mentono, ma non in modo perfido o cattivo; se mai come un bimbo che non vuole ammettere con la mamma di aver rubato la marmellata, anche davanti all’evidenza. Come i bambini, non sono capaci di valutare le conseguenze sugli altri delle proprie azioni: magari si dimenticano di riportarti la macchina e resti a piedi, oppure ti danno appuntamento e poi non vengono e ti lasciano due ore ad attendere a vuoto, ma senza cattiveria o menefreghismo; semplicemente, gli √® passato di mente, o non hanno pensato che la cosa potesse crearti dei disagi. Se gli fai notare i disagi, ti chiedono scusa e per loro la questione √® finita l√¨: amici come prima e pronti a rifarlo di nuovo.
I negri, almeno attorno alla citt√†, potrebbero migliorare senza problemi la propria condizione sociale e uscire dalla miseria; √® solo che non gliene frega niente. Nella loro mente non esiste il concetto di risparmio; e come potrebbe esistere quando la vita √® lunga a malapena abbastanza da mettere al mondo i figli e farli giungere quando va bene alla maggiore et√†? Comunque, d√†gli due lire in mano e le spenderanno immediatamente in puttanate, cominciando dai cellulari e dagli Ipod taroccati cinesi. Anzi, spesso guardano male gli occidentali perch√© pur avendo molti pi√Ļ soldi di loro si presentano in Africa con un cellulare scrauso: √® come se da noi un miliardario andasse in giro coi pantaloni bucati.
I negri adorano la musica, e sono degli ottimi ballerini. Oltre al canonico reggae, ai negri del Mozambico piace molto la techno, perch√© non √® poi cos√¨ diversa dalla loro musica tradizionale basata sui tamburi: per cui si assiste alle scene un po’ stranianti di un vecchio furgone scassato con la gente aggrappata fuori e stesa sul tetto, che attraversa una baraccopoli emettendo musica unz-unz a un volume che assorderebbe un ippopotamo.
Ai negri piacciono un casino le feste; per esempio, si trovano all’aperto all’inizio del pomeriggio del sabato, belli riposati, e attaccano un impianto stereo da migliaia di watt che fa vibrare le pareti dei palazzi a centinaia di metri di distanza; e stanno a suonare e ballare fino alle tre di notte. Non √® previsto che ci sia nel circondario qualcuno che, durante una festa, possa preferire fare altro, o addirittura dormire. Solo a un bianco, alle due di notte e verso la dodicesima ora di musica unz devastante, potrebbe venire in mente di chiamare la polizia – anche perch√© la polizia √® probabilmente l√¨ a ballare con gli altri.
I negri amano i propri figli e le proprie mogli, ma amano in ugual misura le mogli degli altri. “Guarda, c’√® un matrimonio!”, ci ha detto il nostro autista negro, indicando la sposa in abito bianco e agitando la mano nell’internazionale gesto delle corna. I negri si accoppiano con estrema naturalezza, cio√® con qualsiasi altro negro di sesso opposto che ci stia. Adorano i propri figli, ma non si sentono particolarmente obbligati a fornire loro una educazione: da sempre, i bambini crescono allo stato brado in mezzo alla polvere della strada. Riuscire a sopravvivere √® compito del bambino; per esempio, lo stesso negro che capita regolarmente a pranzo dal bianco un giorno s√¨ e l’altro pure non si sognerebbe mai di tenere da parte un po’ del cibo e portarlo al suo bambino. Il genitore maschio, comprati i figli che verranno mediante il pagamento della dote alla famiglia della moglie, pu√≤ fare ci√≤ che vuole. Se √® un bel ragazzo, ci√≤ di solito implica il trovarsi varie amanti e una nuova moglie dopo pochi anni, e/o il morire velocemente di AIDS.
I negri sono i peggiori capi dei negri. I bianchi sono molto ricercati come datori di lavoro; specie quelli che arrivano in Africa in questi anni, con tante buone intenzioni, tanta utopia e tanto senso di colpa. I bianchi europei viziano i negri, gli fanno regali, chiudono un occhio quando fanno casino (cio√® varie volte al giorno), gli ripetono le cose con la pazienza che si usa con i bambini. Il capo negro invece √® uno schiavista; assapora il potere come il cane tenuto per secoli alla catena e finalmente in grado di vendicarsi. Trova naturale sfruttare e arricchirsi il pi√Ļ possibile: se gli dai da gestire cento lire di cooperazione, se ne intascher√† almeno novanta, e solo dieci finiranno ai destinatari originali. Si ritiene molto furbo, ma tanto poi arriva la multinazionale bianca e gli piazza l√¨ un centro commerciale dove tutto costa dieci volte tanto che nel resto della citt√†, e i soldi ritornano prontamente verso l’Occidente (ma anche verso il mondo arabo e la Cina).
Ora, so che alcuni di voi saranno arrivati qui in fondo scandalizzati e staranno gi√† gridando al razzismo, a partire dall’uso del termine “negro” al posto di nero. Intanto potrei dirvi che loro stessi, tra loro, si definiscono negri, e che ogni tentativo di fargli usare il termine preto (nero in portoghese) √® stato accolto con sconcerto: “no, ma perch√©?”. Ma il vero punto √® che i negri sono ben pi√Ļ che neri: la differenza tra negri e bianchi non √® certo nel colore della pelle, tanto √® vero che i neri cresciuti in Occidente e in ambienti socialmente integrati con quelli dei bianchi ne adottano senza problemi i comportamenti e i valori; anche nello stesso Mozambico, nelle √©lite e nelle universit√†, ce ne sono parecchi cos√¨, senza nemmeno essere mai stati all’estero. A quel punto, per√≤, sono neri ma non pi√Ļ negri, e anzi i negri spesso li guardano come dei traditori.
Il problema che gli occidentali che non sono mai stati in Africa hanno con l’uso del termine “negro” √® in realt√† causato dal loro fondamentale razzismo, che sta nel fatto di applicare il proprio insieme di valori anche all’Africa stessa. Il bianco, con protervia razzista, ha deciso che le proprie equazioni “gran lavoratore = buono, pigro = cattivo, efficiente = buono, disorganizzato = cattivo” si devono applicare all’intero pianeta; poi va in Africa e si accorge che l√† non √® cos√¨. All’inizio l’approccio razzista si concretizzava nel punire i neri perch√© erano negri: vedi apartheid, linciaggi o quando va bene rieducazioni forzate all’etica del lavoro. Poi abbiamo finalmente capito che ci√≤ √® Male; ma ci√≤ non cambia la natura dei negri.
Quindi, quando al giorno d’oggi l’occidentale pieno di buone intenzioni arriva in Africa e si accorge di come girano le cose, il suo cervello va in tilt: per evitare di concludere che i negri sono tutti cattivi, il bianco si inventa le peggiori assurdit√†. Per esempio nega la realt√†: ho sentito gente sostenere che “l’Africa non √® poi cos√¨ disorganizzata”, mentre ripeteva per la quarta volta l’ordinazione al ristorante. Pi√Ļ spesso, si prende la colpa: “sono cos√¨ solo perch√© noi li abbiamo schiavizzati e sfruttati per secoli”. E’ vero che li abbiamo schiavizzati in modo indegno e che abbiamo rubato loro un sacco di risorse naturali (che peraltro loro non sapevano come estrarre e nemmeno come utilizzare, e portando in cambio infrastrutture che loro non sapevano come costruire), ma non √® vero che questa sia la causa della loro cultura; anzi, tanto di cappello a loro per averla conservata nonostante legioni di missionari salesiani che volevano convincerli di quanto sia giusto lodare il Signore lavorando in fabbrica. Anche questi sono approcci razzisti, perch√© continuano a sottintendere che i negri, per essere da noi apprezzati e accettati, devono per forza comportarsi come i bianchi, e vivere in citt√† sovraffollate cavalcando scatole di latta comprate a rate. L’unico approccio onesto, secondo me, √® lasciare che vivano da negri, senza applicare a loro i nostri metri di giudizio, e permettergli finalmente di decidere da soli, tutti insieme, cosa vogliono fare delle proprie societ√†, e quale sia per loro il giusto compromesso tra fatica e sviluppo.
La negritudine, in realt√†, √® un sistema di vita e di morale che √® molto pi√Ļ naturale, pi√Ļ semplice, meno alienato, meno frustrante e meno soffocante del nostro. Ha i suoi lati negativi, tra cui l’impossibilit√† di generare alcun tipo di sviluppo economico o una ricchezza materiale anche vagamente comparabile alla nostra, nonch√© una vita pi√Ļ breve e pi√Ļ soggetta a malattie. Per noi √® immorale, perch√© non √® basato sul sacrificio. Facilmente, per√≤, √® soltanto invidia.
[tags]viaggi, africa, europa, razzismo, società, sviluppo, sottosviluppo, negri[/tags]