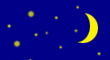Come avrete notato, alla fine non ho scritto quasi nulla del mio viaggio di quest’anno, essenzialmente perché è stato talmente intenso che non ne ho avuto il tempo. Visto che alcuni dei miei lettori storici si sono lamentati, ho buttato giù velocemente un testo di alcune pagine, che pubblicherò a puntate. In superficie è un manuale per mettersi alla guida negli Stati Uniti, utile a chi prima o poi, per lavoro o per diporto, si trovasse a doverlo fare. In realtà , l’obiettivo è anche quello di descrivere in modo divertente le caratteristiche della società americana, e farvi viaggiare un po’ con il pensiero.
Introduzione
Guidare negli Stati Uniti, per un italiano, è un’esperienza molto particolare. Nonostante gli americani guidino dal lato giusto della strada e nonostante anche lì i semafori usino rosso, giallo e verde, questi sono più o meno i soli due punti in comune tra noi e loro. Il resto richiede al guidatore italiano uno sforzo di adattamento, che sarà peraltro centrato su un problema fondamentale: non addormentarsi al volante.
Avete presente il nostro stereotipo del vecchietto con cappello in testa alla guida di una fiammante Fiat 131, estratta dalla rimessa solo per il viaggetto della domenica, che viene in città a piazzarsi nella corsia centrale dei viali a 35 chilometri orari? Ecco, quello è il prototipo del guidatore americano medio, solo che sotto il sedere non ha una Fiat 131, ma un SUV da tre tonnellate. Gli americani al volante, visti da un italiano, giustificano una abbondante quantità di bestemmie e, se l’italiano ha confidenza con il lessico americano, l’uso frequente del termine “retarded”. Molti sono i fattori che spiegano un simile comportamento, ma i principali sono due: le auto e la disciplina.
Le auto americane
Le auto americane sono una dimostrazione pratica di cosa accada secondo l’evoluzionismo darwiniano quando individui di una stessa specie vengono improvvisamente divisi da un oceano di distanza e si sviluppano separatamente per molte generazioni: le auto americane infatti sono riconoscibilmente simili alle auto europee, ma presentano differenze profonde. Esse racchiudono in sè elementi presi con cura da tutti i veicoli del mondo: l’accelerazione di un camion, la manovrabilità di un camper, la parcheggiabilità di una limousine, la spaziosità di una utilitaria, i consumi di una Ferrari. Peggio ancora se, come successo a me, il vostro autonoleggio vi rifila un clone giapponese di un’auto americana (nello specifico, una Mitsubishi Galant).
Sicuramente, essendo europei, voi avrete chiesto al noleggio un’auto piccola. E loro vi daranno un’auto “piccola”, ovvero lunga sui cinque metri, di cui un metro orizzontale di cofano e un metro orizzontale di baule, dato che il concetto di portellone posteriore verticale là non è ancora arrivato; due tonnellate di lamiera di cui buona parte con funzioni essenzialmente estetiche, visto che l’abitabilità non è poi tanto migliore delle nostre berline (vi verrà il dubbio che gli americani valutino le auto in funzione della quantità di lamiera che contengono). Provate a fare manovra con un’auto così: è impossibile, perché non si vede dove finisce, né davanti né, soprattutto, indietro. Immaginatevi di dover mettere la retromarcia per entrare o uscire da un parcheggio: è un incubo, anche perché un’altra cosa che là non è arrivata sono i sensori di ostacolo in manovra.
Se vi state chiedendo allora come facciano gli americani ad andare in retromarcia, la risposta è semplice: non lo fanno. Tutto il sistema stradale è concepito in modo da evitare il più possibile l’uso della retromarcia, che avviene solo in situazioni dove il retro è tendenzialmente libero da ostacoli – ovvero, per uscire da parcheggi a lisca di pesce o dall’immancabile vialetto del garage della loro villetta suburbana. Le strade senza uscita, se appena è possibile, finiscono con un grande slargo o meglio ancora con una rotonda che vi permette di girare senza problemi.
Di conseguenza il parcheggio parallelo accanto al marciapiede, che da noi è la norma, negli Stati Uniti è meno frequente. Infatti, gli americani hanno risolto il problema del parcheggio urbano in modo molto semplice: abbattendo interi isolati dei centri cittadini e trasformandoli in sei piani di parcheggio a lisca di pesce. Immaginate di camminare per il centro di Torino dove però un isolato su quattro è stato sostituito da un autosilo: ecco, i centri americani sono generalmente così.
In alternativa, nelle zone appena un po’ meno centrali, semplicemente hanno abbattuto l’isolato per trasformarlo in un piazzale dove parcheggiare a pettine in file ordinate, come i nostri piazzali dei centri commerciali, ma in più protetti da filo spinato e con un messicano, nero o asiatico che riscuote la tariffa (di solito fissa, indipendentemente dalla durata della sosta) ed evita che vi vandalizzino la macchina (la notte però la guardia spesso se ne va e lì son cavoli vostri). In questo caso, l’americano medio non di rado si concede, pur con un po’ di paura, una manovra da brivido: se trova due posti contigui su due file affiancate, entra dal primo ma prosegue e si ferma nel secondo, perché poi così potrà uscire in avanti, evitando di mettere la temuta retromarcia.
Ad ogni modo, in molti centri urbani è previsto anche il parcheggio parallelo a bordo strada, ma solitamente è pieno di limitazioni, riportate in cartelli rettangolari piccoli piccoli che dovrete leggere con attenzione. Tipicamente, non solo si paga al più vicino parchimetro (ma si pagano anche i parcheggi-edificio, in generale per l’americano urbano è scontato che ogni movimento costi anche 10 o 15 dollari di sosta) ma vi sono limiti temporali (es. massimo due ore) e ore vietate (es. una notte a settimana per la pulizia strade); non di rado, la strada è riservata ai residenti. E soprattutto vengono disegnati sull’asfalto gli angoli dei singoli posti, riservando sette-otto metri per auto – quello che vi serve per uscire, e spesso anche entrare, senza dover fare retromarcia.
La seconda caratteristica delle auto americane che giustifica il comportamento alla guida è il cambio automatico. Se pensate di andare laggiù a guidare per qualche motivo, è bene che siate preparati – altrimenti vi troverete in un parcheggio a lisca di pesce con un addetto dell’autonoleggio che vi dice “ok, vada pure” e voi nell’imbarazzo di non sapere bene come far avanzare la macchina (successe a me nel 2000).
Il cambio automatico ha solo due posizioni utili, P (parcheggio) e D (guida, ovvero marcia avanti); per cambiare bisogna premere il pulsante sulla manopola del cambio e spostare la leva avanti o indietro (il nostro sistema a due file di posizioni è troppo complesso, la leva americana va solo avanti o indietro). La posizione di parcheggio equivale a lasciare la marcia inserita da fermi, e di solito la macchina non vi permetterà nemmeno di estrarre le chiavi se non l’avete messa. Esistono poi anche N (folle) e R (retromarcia), ma come detto non le usa nessuno. Non appena inserite la D, la macchina comincia a muoversi in avanti a passo d’uomo, al che voi potete reagire premendo il freno, per tenere la macchina ferma con la marcia inserita, o accelerando per partire veramente. Ovviamente non c’è il pedale della frizione, sostituito da un padellone per quello del freno che occupa quasi tutto lo spazio dei piedi.
Fin che siete in autostrada o in città e non dovete fare manovre particolari, il cambio automatico è una meraviglia: a patto di restare col freno premuto ai semafori, non dovrete mai cambiare. Anche le partenze in salita funzionano bene, permettendovi di girare per le strade di San Francisco senza problemi e senza dover usare il freno a mano. Le cose sono però diverse se vi trovate in situazioni dove avete bisogno di gestire voi il cambio – ad esempio una strada in salita, o un sorpasso fuori città . Lì, ovviamente, scattano le bestemmie, perché il vostro cambio automatico insisterà a farvi arrancare con una marcia troppo alta o si rifiuterà di scalare per darvi un po’ di ripresa fino a quando lo spazio per il sorpasso non sarà finito.
E poi, c’è il vero punto debole del cambio automatico: la discesa. Un cambio automatico si basa sulla velocità : quando la velocità aumenta, mette una marcia più alta per permettere di continuare l’accelerazione. Il problema è che il cambio automatico non è in grado di distinguere se la velocità sta aumentando perché voi volete accelerare, oppure se la velocità sta aumentando perché voi siete nel mezzo di una discesa verticale in mezzo alle montagne e vorreste solo riuscire a rallentare ma non potete. In pratica, il cambio automatico non permette di usare il freno motore, e le vostre chance di non ammazzarvi in discesa si riducono all’uso del freno normale, per rallentare un barcone da svariate tonnellate di lamiera su strade spesso molto ripide (gli americani non si fanno problemi, se c’è una montagna tirano dritto appena possibile).
Un buon modo di gestire la situazione è quello di frenare solo per lo stretto necessario, lasciando correre allegramente l’auto dove possibile (in fondo la strada è ripida ma dritta). Il problema è se, come successo a me giù dal passo Towne all’uscita della Valle della Morte, vi trovate davanti un americano medio, che terrorizzato dall’idea di sfrecciare su una statale a più di 70 chilometri all’ora percorre la discesa aggrappato ai freni, fermandosi ogni tanto nelle numerose “brake check area” (come potete immaginare, tutte le discese americane sono precedute da accorati appelli a controllare se funzionano i freni, e spesso sono dotate di corsie di emergenza in salita e altri dispositivi). A quel punto, in assenza di possibilità di sorpasso, sarete costretti anche voi a passare la discesa aggrappati al freno fin che l’ostacolo non si toglie di mezzo. Dopo due minuti, il freno comincia a saltellare, e dopo cinque minuti l’abitacolo viene invaso da un distinto odore di bruciato. A quel punto il pedale del freno comincia a saltellare vistosamente, l’effetto frenante è quasi nullo e voi potete solo sperare che la discesa finisca presto, per fermarvi a bordo strada e assistere a un denso fumo bianco che esce dalle vostre ruote.
A quel punto ho scartabellato il manuale dell’auto per capire: possibile che non ci fosse alternativa? Alcune auto hanno una posizione aggiuntiva sul cambio automatico, ad esempio “2” o “3”, che vuol dire che al cambio automatico non viene permesso di andare oltre tale marcia; ma la mia non aveva nulla. Alla fine ho scoperto che si poteva attivare lo “sports mode”, che era… il cambio manuale, o meglio la possibilità di ordinare al cambio di scalare; infatti, secondo gli americani, per voler cambiare manualmente bisogna necessariamente essere un pilota di Formula 1!
[tags]stati uniti, auto, guida[/tags]