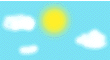Rieccomi qui, dopo tre giorni di giro a Pechino. Forse pensavate che la polizia cinese mi avesse portato via (qualcuno ci sperava anche) e invece no, è che portarmi dietro il PC sembrava esagerato, anche perché all’andata abbiamo preso il treno notturno (e già quella è un’esperienza che meriterà un post).
Per questo racconto serale però non parlerò di Pechino, anche perchè la visita di stamattina alla Città Proibita è stata una delle esperienze più miserabili della mia vita: immaginate la calca del Festival delle Sagre, addensatela di tre o quattro volte, moltiplicatene l’estensione per venti e avrete una vaga idea di cosa abbiamo trovato. Mentre ero lì pensavo che vale davvero la pena di sconsigliare di venire a Pechino in agosto, perlomeno nei fine settimana… E ovviamente va sottolineato che gli stranieri erano non più del venti per cento: considerate che c’è circa un miliardo di cinesi che non ha mai potuto spostarsi dal suo paesello e che ora si trova la possibilità di visitare il centro della Cina in torpedone e pentole, e immaginate cosa succederà ai luoghi turistici di questo Paese nei prossimi anni.
Volevo dunque raccontare invece della cena di ieri sera â no, non dell’anatra alla pechinese, che è buona ma comunque secondo me non vale i soldi che te la fanno pagare e il mito che la circonda (alla fine, stringi stringi, è un burrito con salsa di soia). Ma della signora che abbiamo invitato, dopo averla reperita per conoscenze varie.
E’ una signora italiana che è venuta per la prima volta a Pechino nel 1988, mentre studiava cinese all’università ; e dal 1992 vi è venuta a vivere, sposando un cinese e rimanendo qui per quasi vent’anni. Ha dunque vissuto direttamente tutta l’evoluzione della società cinese, e la sua conclusione è stata che per lei che ci vive è infinitamente meglio adesso, ma che chi la visita ora non potrà più vedere ciò che la Cina è stata per secoli e che sopravviveva ancora fino a quindici anni fa.
Ha cominciato descrivendoci della sua esperienza di studente straniero, che allora doveva vivere in una foresteria separata dentro l’Università ; a ogni studente lo Stato, che allora era comunista sul serio, forniva un corredo fatto di un letto di ferro, un materasso spesso pochi centimetri, una sedia e un tavolino di legno per studiare, e un armadio di cartone ad un’anta. Fine: non si poteva avere altro, perchè come in tutti i sistemi comunisti non bastava avere i soldi per procurarsi oggetti, a meno di non ricorrere ai prezzi folli e ai pericoli del mercato nero. Per poter comprare qualsiasi cosa, dal riso ai vestiti, serviva un coupon; lo Stato decideva quanti coupon potevi avere ogni anno per ogni bene, in base alla tua professione e al tuo livello di anzianità , e tu al massimo quello potevi avere e nulla più.
Quello era il momento delle prime libertà : tra gli studenti circolavano giornali e notizie sul resto del mondo. Il contatto con gli occidentali non era comunque gradito, tanto che lei conobbe il suo futuro marito il quale, semplicemente per essere stato visto parlare con lei un po’ di volte, fu punito dopo la sua partenza. L’anno dopo ci furono le manifestazioni studentesche, che subito furono represse, ma che fecero capire al regime che il livello di chiusura e la povertà che esso generava non erano più sostenibili.
La signora ci ha dunque raccontato di quando il partito annunciò con grande enfasi che da quel momento in poi veniva introdotta, ovviamente tra molti vincoli, la libertà di commercio a titolo privato. Nel giro di una settimana i custodi dello studentato misero su un bazar e cominciarono a farsi i soldi…
Nella prima metà degli anni ’90 cominciarono timidamente a nascere le aziende private, sia cinesi che straniere (gli stranieri non potevano possedere più del 50%, limite che poi è stato tolto alcuni anni fa). Ovviamente quasi tutti i cinesi â tranne pochi pionieri, che ora sono in buona parte tra i mille uomini più ricchi del pianeta â le schifavano e preferivano continuare a lavorare per le âunità di lavoroâ (in un sistema comunista classico non solo tutte le attività economiche sono dello Stato, ma non esiste nemmeno il concetto di âaziendaâ: tutto è semplicemente un pezzetto infinitesimo dei vari ministeri). L’unità di lavoro era la mamma, come noi le fabbriche fino alla prima metà del Novecento: ti dava la casa, la mensa, l’assistenza. Le case non avevano i bagni, ma vi erano (vi sono tuttora) toilette pubbliche ogni isolato e docce in comune in fabbrica: la gente si lavava al lavoro prima di tornare a casa.
La signora venne a lavorare qui come interprete per le prime sparute aziende italiane, entrate negli anni precedenti per accordo diretto tra il governo cinese e il PCI, e si sposò con il suo cinese. Allora la norma era che l’unità di lavoro dello sposo assegnasse alla nuova coppia una casa, condivisa con un’altra coppia per i primi cinque o sei anni, trascorsi i quali il lavoratore avrebbe avuto una promozione â che avveniva principalmente per anzianità e poco per merito â e con essa un appartamento di livello superiore e così via (per questo motivo le case cinesi cadevano a pezzi, dato che nessuno ne era proprietario, nessuno ci restava per più di qualche anno e dunque nessuno aveva interesse a investirci).
Come coppia mista, allora assolutamente rara, loro ebbero il privilegio di avere da subito una casa da soli: una costruzione semi-fatiscente con una espansione abusiva in mattoni che crollò appoggiandoci la mano, perché non ci avevano nemmeno messo la malta non essendo riusciti a procurarsela. Tuttavia la casa aveva un problema: non solo non aveva il bagno, ma non aveva nemmeno il gas; e il livello del lavoratore non era sufficiente ad avere diritto ai coupon per le bombole di gas. Dunque non si poteva cucinare; la cosa fu risolta solo quando il capo della signora, ottenuto un appartamento in un palazzo nuovo e dotato dei tubi del gas, donò sottobanco alla signora la sua vecchia bombola e la tesserina che autorizzava alla ricarica (ovviamente trasportandosi la bombola a spalle fino al negozio).
In Italia, racconti di questo genere risalgono come minimo agli anni ’40, se non prima; eppure qui stiamo parlando della prima metà degli anni ’90, meno di venti anni fa. Capite allora perché ora i cinesi siano così orgogliosi della loro ricchezza e del loro splendore, e allo stesso tempo siano determinati ad emergere, per certi versi calpestando tutto e tutti senza pietà , per altri impegnandosi al massimo.
A parte la generazione dei ventenni, che vivono di McDonald’s e magliette firmate, tutti gli altri hanno vissuto sulla loro pelle questo sistema (per esempio uno dei docenti universitari ci ha parlato di Mao con odio evidente spiegandoci che lui, bambino a inizio anni ’70, non aveva potuto studiare â una attività pericolosamente borghese â ma era stato subito spedito a lavorare nei campi e aveva dovuto aspettare la morte di Mao per poter avere un’istruzione). Ora che molti di loro â anche se sempre una minoranza rispetto agli 800 milioni di contadini straccioni dell’interno â possono comprarsi un’auto, un cellulare, i vestiti che vogliono, possono scegliere che cosa studiare e che lavoro fare (nel sistema comunista entrambe le cose erano decise dallo Stato per te, in base alla pianificazione economica generale), possono prendersi addirittura due giorni di riposo a settimana pur lavorando dodici ore al giorno negli altri, hanno tutte le intenzioni di godersi la situazione.
Ancora quindici anni fa era tutto all’età della pietra: la signora nel 1995 era andata a lavorare come traduttrice in un cantiere di una diga nel Sichuan, e loro erano i primi occidentali ad aver messo piede in quella zona (allora ancora vietata agli stranieri) dal 1950. Avevano reclutato come operai le minoranze etniche del posto, gruppi semi-nomadi che giravano scalzi, vivevano cacciando e raccogliendo quel che trovavano e non avevano mai avuto in mano del denaro in vita loro. Al pagamento dello stipendio del primo mese, dopo poche ore i soldi erano già spariti: così dovettero insegnargli loro il concetto di risparmio. Con i primi soldi la tribù comprò un bene preziosissimo: ciabatte di plastica rosa per tutti. Nel giro di breve tempo però scoprirono i modi classici di spendere i soldi: fumo, alcool e prostituzione (il giorno di paga richiamava prostitute da decine di chilometri di distanza). Alla fine, comunque, molti di questi divennero operai qualificati: e così ne convertì al proletariato di più l’arrivo del capitalismo che quarant’anni di comunismo.
[tags]viaggi, cina, pechino, comunismo, capitalismo[/tags]