La solitudine del numero dieci
Quando io ero bambino, il calcio era un’altra cosa. Il calcio era una festa, perché si giocava di domenica pomeriggio, allo stadio in piedi sotto il sole, o attaccati alla radiolina di casa, o passeggiando al Valentino, fermando tutti i passanti ogni minuto per chiedere se per caso il Toro avesse già segnato. Il calcio era una festa perché era uno spettacolo, perché c’erano decine di migliaia di persone che sospiravano all’unisono, e magari non avevano la coca cola in braccio e il posto preassegnato col seggiolino ottimizzato a forma di culo, e nemmeno lo schermo piatto per rivedere a casa ogni scaracchio in super-slow-motion, ma avevano il sole, il cielo e la speranza di un gol e di qualcuno che costruisse per loro un mondo migliore.
E avevano il numero dieci: tutte le squadre che valessero qualcosa avevano un numero dieci, o se non era un dieci era un sette o un sei o un undici, ma era un giocatore diverso dagli altri. Uno che con la palla faceva le magie, uno che con la palla faceva sognare; uno che da solo valeva il prezzo del biglietto. Uno che faceva cose che nessun altro giocatore in campo, anzi nessuna altra persona al mondo era capace di fare, come, che so, ribaltare in un attimo il risultato di una guerra – una guerra vera, con morti e feriti – con un semplice pugno alzato verso il cielo nel secondo preciso del destino.
Il numero dieci era un artista e spesso giocava da solo; nei casi più estremi, i compagni si limitavano a passargli la palla e ad aspettare che facesse lui. Era un privilegiato, spesso antipatico come pochi; fuori dal campo, non di rado tagliava gli allenamenti, si faceva di coca e sparava ai giornalisti. Anche quando era più morigerato, era comunque un diverso; oggetto di ammirazione ma anche di invidia (dei compagni) e di odio (degli avversari). Del resto l’approccio italiano per marcare i numeri dieci era quello di spaccargli le gambe ad ogni occasione sin dal primo minuto: Gentile e Bergomi conquistarono la fama picchiando Maradona. E se un giocatore qualsiasi può sempre vivacchiare e passare la palla, il numero dieci era maledetto a fare miracoli per contratto: o stupiva o falliva.
Poi, vent’anni fa, nel calcio arrivarono Sacchi e Berlusconi, e condannarono i numeri dieci all’estinzione. Il genio divenne un optional, sostituito dagli steroidi, dagli schemi scientifici, dagli allenatori col portatile. Decenni di frustrazione del resto del mondo vennero alla luce: ma perché privilegiare uno più degli altri, ma perché dipendere da una persona sola. Dipendere dall’individuo è sbagliato, noi vogliamo il sistema, il calcio industriale, l’investimento a ritorno garantito; il giocatore dal rendimento mediocre ma costante, il gioco pianificato a tavolino e proprio per questo prevedibile ma certo. Il tifoso schedato e ridotto a numero, con la sua maglietta rigorosamente ufficiale e coperta da copyright, uguale a tutte le altre, che canta l’inno previsto dall’azienda di marketing, in vendita su CD al supermercato e pronto ad essere sostituito da una canzone nuova l’anno dopo, ché l’economia deve sempre girare.
Nel calcio e nella vita, i numeri dieci sono una specie ormai estinta. Non è che non ne nascano più, ma il genio gli viene sradicato a bastonate proprio come una volta si costringevano i mancini a usare la destra. A seconda degli investimenti nella pianificazione industriaale del giocatore e della forza aziendale di chi li possiede, o diventano dei bovini gonfiati come Del Piero, o diventano dei falliti come Pinga e Rosina. Se provano un dribbling, tutti si incazzano: “e passa quella palla!”.
C’è oggi, nel calcio e nella vita, la retorica della squadra. Il gioco di squadra, il collettivo, l’organizzazione, l’egualitarismo. Una volta erano valori che associavamo ai freddi paesi del Nord o ai formicai dell’Oriente, restando orgogliosi dell’inventiva e della creatività italiana, su cui si basavano le nostre fortune e le nostre glorie sin dai tempi di Dante e di Leonardo. Ma anche da noi, ora, l’individuo più dotato o più fortunato della media è visto con intrinseco fastidio.
La squadra è importante, da soli non si può fare tutto; ma neanche tutti possono fare tutto. Un italiano medio, preso a caso per strada, non può scrivere la Divina Commedia; è già tanto se sa scrivere un SMS. Nemmeno dieci italiani possono scrivere la Divina Commedia. E’ molto, molto improbabile che anche un milione di italiani, persino se ben organizzati in una struttura pianificata, possano scrivere la Divina Commedia. Dante, lui sì, poteva scrivere la Divina Commedia. Probabilmente come centravanti faceva cagare, e magari come persona era uno stronzo di prima categoria; ma nel suo briciolo di genialità poteva fare qualcosa che pochi altri, forse nessuno, avrebbero potuto fare, e con questo segnare il futuro della sua nazione a vantaggio di tutti.
In Italia, la retorica della squadra dà il peggio di sé; è diventata una esaltazione della mediocrità . I nostri numeri dieci, per salvarsi, sono tutti all’estero; a scoprire la cura del cancro in una Università americana o ad aprire gelaterie in Cina. L’Italia, un paese socialista intrappolato alla periferia del Vaticano, ha imparato velocemente a disfarsi del talento: perché conviene a molti. Conviene ai mediocri, ai raccomandati, ai piacioni e ai maneggioni, ai numeri due e cinque e quattordici e ventisette, che altrimenti sarebbero condannati ai margini dei riflettori. E’ molto più popolare promettere gloria per tutti e sostenere che anche Pepe e Marchisio possono giocare un mondiale da protagonisti; salvo poi tornare a casa al primo turno, umiliati dalla Slovacchia e dalla Nuova Zelanda.
[tags]italia, calcio, mondiali, maradona, berlusconi, socialismo, comunismo, società , egualitarismo, meritocrazia, competizione, talento[/tags]
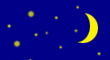


25 Giugno 2010, 22:29
Mah, mi sembra tutto sconclusionato (a partire dall’imprecisione su Berlusconi: ha spesso fatto fuori gli allenatori perché non facevano giocare i suoi numeri 10, da Savicevic all’ultimo Ronaldinho). Credo che bisognerebbe anche fare un’onesta analisi di coscienza ogni tanto: il talento vero sa anche imporsi, se non lo fa è un Giovinco o un Recoba, bello come idea, ma sostanzialmente inutile.
26 Giugno 2010, 16:49
Sempre a sognare l’uomo della provvidenza… non è la risposta giusta.
30 Giugno 2010, 10:07
C’è ancora, grazie a dio, un giocatore sempre diverso dagli altri. I tempi cambiano: non è più quello che da solo ti porta alla vittoria, ma è quello che ti permette di non affondare. E’ l’ultima speranza, quello che non può sbagliare dopo che tutti gli altri l’hanno fatto, quello che mette la faccia avanti quando gli altri si girano per proteggersi, quello che non deve e non può aver paura di farsi male. E’ quello che riceve la massima punizione anche quando l’infrazione non l’ha commessa lui. Ed è quello che resta sempre nell’ombra perchè, qualsiasi cosa faccia, “ha fatto il suo dovere”.
E’, fortunatamente, il giocatore che ancora ha una sua personalità diversa, un ego spesso sproporzionato, un’altra prospettiva per vedere le cose. In silenzio, da solo, da dietro.
Certo, non ci sono più neanche i numeri 1 di una volta, ma ce n’è ancora uno in ogni squadra, necessariamente, ed è sostituibile solo con un altro uguale.
Di questi tempi, anche conservare lo 0-0 può essere cosa non da poco.
1 Luglio 2010, 14:25
Se posso fare un appunto a quanto hai scritto, basato sulla mia esperienza, l’inizio della scomparsa del “dieci” avviene quando si afferma il c.d. calcio totale dell’ Olanda e dell’Ajax e, guarda caso, uno dei primi a cercare di recepire questo nuovo modo di giocare è proprio il Torino di Radice …
All’epoca giocavo in un campionato semiprofessionistico e ricordo ancora come passammo, nel giro di un anno, dal libero alla difesa in linea e come divennero molto più intensi gli allenamenti.
E il “modello” era proprio la squadra di Radice …
6 Agosto 2010, 15:07
Che nostalgia…
Mi hai fatto ricordare i tempi in cui ero ragazzino e che le stesse cose si dicevano a proposito del fatto che Bearzot lasciava a casa Beccalossi e convocava Oriali e Marini. Allora però abbiamo vinto i mondiali battendo l’Argentina di Maradona e il Brasile di Zico e facendo giocare in finale Beppe Bergomi al posto dell’infortunato Antognoni. Così Bearzot diventò un genio e Beccalossi una pippa…
A parte questo, come scritto da Apis, il calcio moderno è nato in Olanda non ad Arcore. Per una volta Berlusconi non c’entra.