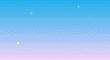Una visita al CIE
Ieri ho avuto la possibilit√† di visitare il CIE (Centro Identificazione ed Espulsione) di corso Brunelleschi a Torino. Credo che sia quindi utile portarvi con me in un rapido giro e raccontarvi le cose che ho appreso, di modo che ognuno possa formarsi una opinione pi√Ļ informata sul senso di questi centri.
Il CIE nasce nel 1998, a seguito di una direttiva europea; al quartiere fu promesso che sarebbe stato l√¨ solo un paio d’anni, ma quindici anni dopo √® ancora l√¨. A un costo iniziale di 18 milioni di euro si √® aggiunta una ristrutturazione, completata tre anni fa, per altri 14 milioni di euro, che lo port√≤ ad essere il pi√Ļ grande d’Italia. Il CIE non √® un carcere, e non √® costruito coi criteri di sicurezza di un carcere, ma √® comunque un luogo in cui risiedono dei “trattenuti”, persone straniere clandestine e/o dall’identit√† sconosciuta in attesa di essere identificate ed espulse: per questo ci sono gabbie e barriere.
L’identificazione non consiste solo nel dare un nome alle persone, ma soprattutto nell’ottenere che il loro Paese se li riprenda, emettendo un lasciapassare che gli permetta di affrontare il rimpatrio (il 95% delle persone difatti arriva al CIE senza documenti, dunque anche senza un passaporto per poter passare la frontiera). In diversi Paesi europei non vi √® limite al tempo di trattenimento delle persone nei CIE, ma in Italia il limite √® di 18 mesi; di norma, comunque, se lo Stato non riesce a rimpatriare qualcuno entro sei mesi lo lascia libero, perch√© a quel punto si presume che non esista la possibilit√† concreta di rimpatriarlo. Esistono diversi altri motivi per cui non si pu√≤ essere trattenuti nel CIE; se si √® minore o donna incinta, se si √® diabetici, persino se si hanno fratture che richiedono l’ingessamento (ci si pu√≤ far male da soli per uscire). Alla fine, mediamente solo il 50% delle persone che entrano nel CIE viene effettivamente espulso e rimpatriato; gli altri tornano liberi con un foglio che gli ordina di andarsene dall’Italia, cosa che ovviamente non fanno, a meno di non riuscire ad andare a nord.
I “trattenuti” hanno a disposizione degli avvocati, che spesso vengono ringraziati con disegni, lettere e in un caso addirittura con un murale dipinto nella loro stanza; e dei medici, che ne controllano lo stato di salute. Spesso partono scioperi della fame con implorazione “fatemi uscire sto morendo” che poi risultano finti, perch√© le persone rifiutano il cibo ma poi trovano il modo di mangiare altra roba giunta dall’esterno; anche noi siamo stati fermati da un detenuto che lamentava di avere l’epatite, con immediata mobilitazione di alcune consigliere, a cui il medico ha risposto che non era il caso.
La cosa che colpisce in realt√† √® quanto √® piccolo il CIE, pur essendo il pi√Ļ grande d’Italia. Tre anni fa aveva 210 posti, divisi in sei aree separate di cui una femminile, ma adesso ne ha soltanto 98, di cui soltanto 85 sono occupati (il 60% da persone fermate a Torino e provincia, il resto da fuori). In ogni area potrebbero vivere 35 persone, divise in cinque camerate da sette, ma di solito ce ne sono al massimo una ventina.
Ogni camerata √® dotata dei letti, di alcune caselle di legno, di un bagno e di un televisore; non ci sono armadi, perch√©, ci hanno spiegato, venivano spaccati e usati come armi. Il risultato √® ovviamente quello di una scarsa intimit√†, a cui i “trattenuti” rimediano come possono.
Ogni area ha poi una casetta separata utilizzata come mensa e luogo di ritrovo, nella quale vi sono anche un lavandino (studiato per non poter essere divelto) e un telefono.
L’intero centro, pur sorvegliato da ragazzi dell’esercito in tuta mimetica, √® gestito dalla Croce Rossa, che ha vinto il relativo appalto. Tra le cose che fanno c’√® la gestione dei pasti, che vengono preparati e distribuiti caldi ma impacchettati (non ci sono fuochi, gas o attrezzi per scaldare dentro le gabbie).
Loro cercano di soddisfare i “trattenuti” almeno in questo, per cui ognuno pu√≤ indicare le proprie preferenze (su 85 ospiti vi sono 81 menu diversi) e il numero di pasti √® sovrabbondante, per cui chi vuole pu√≤ fare il bis e anche essere un po’ schizzinoso: ad esempio abbiamo visto un ospite prendere il riso attraverso l’apposita feritoia, non gradirlo, scaraventare fuori tutto il pacchetto e chiedere un’altra cosa.
Ogni “trattenuto” riceve dalla Croce Rossa 3,50 euro al giorno, che pu√≤ utilizzare per ricariche telefoniche, per comprare le sigarette o per poco altro; comunque, spesso parenti e amici inviano vaglia postali, oltre ai soldi (spesso non pochi) che ognuno di loro aveva in tasca quando √® stato fermato. Oltre alla televisione, sono disponibili un campo da calcio e dei canestri da basket: non c’√® molto con cui ingannare il tempo.
Forse vi starete chiedendo come mai, su 210 posti originari, ce ne sono ora soltanto 98. Il motivo è che gli altri posti sono stati devastati nelle periodiche rivolte, e così molte delle camerate Рe anche una intera area Рsono chiuse, mentre gli altri vivono tra le tracce degli incendi passati: qui, ad esempio, sono in uso solo due camerate su cinque.
Vi sono diversi motivi per cui le rivolte sono cos√¨ frequenti. Innanzi tutto, a differenza di ci√≤ che avveniva molti anni fa, oggi quasi mai chi entra in un CIE √® un clandestino appena sbarcato; la popolazione √® “paracarceraria”, ovvero quasi tutti sono in Italia da molto tempo e sono gi√† stati per molti anni in carcere, uscendone senza permesso di soggiorno e quindi venendo poi ri-fermati e inviati al CIE. L’assurdit√†, difatti, √® che per legge non possono essere avviate le procedure di identificazione e rimpatrio mentre sono in carcere, dunque devono scontare la pena, uscire, finire in un CIE e poi aspettare mesi l√¨ dentro per lo svolgimento delle procedure. E loro stessi dicono: almeno in carcere sapevo perch√© ero dentro, ma qui? E perch√© non avete svolto le procedure mentre ero in carcere? Aggiungete che il livello di sicurezza √® molto pi√Ļ basso e che fuggire √® possibile – qui sotto vedete l’angolo da cui, arrampicandosi, tutti provano a scappare, e che non si pu√≤ bloccare meglio per evitare il rischio che si ammazzino scappando, con conseguenti responsabilit√† penali e polemiche politiche – e capirete perch√© due volte al mese c’√® una rivolta.
Inoltre, nel CIE di Torino (non dappertutto √® cos√¨) ai “trattenuti” viene lasciato un telefonino, purch√© privo di fotocamera (se no gli chiedono di spaccarsela). Molti di loro sono in diretto contatto con l’esterno, dove sia i parenti che i centri sociali li aiutano a ribellarsi. Tempo fa, per esempio, fu lanciato dall’esterno un seghetto col quale furono tagliate le gabbie per poi cercare di uscire (qui vedete la riparazione).
In pi√Ļ, grazie al telefonino e alla televisione, loro sono informati di ci√≤ che succede negli altri CIE e in Italia, e dunque a ogni episodio di razzismo che finisce sui giornali o che gli viene raccontato (vero o falso che sia, spesso vengono messe in giro voci ad hoc) o a ogni rivolta in altri CIE parte una rivolta anche a Torino.
Qual √® la conclusione? Sicuramente questo √® un luogo spiacevole; vedere delle persone dentro delle gabbie non fa piacere a nessuno, e il luogo – pur con tutto l’impegno della Croce Rossa – √® comunque grigio, piuttosto sporco, degradato, con l’aspetto da campo profughi e in pi√Ļ le gabbie. L’impressione per√≤ √® che il problema di fondo sia l’inconcludenza italica, per cui si decide di espellere delle persone “ma non troppo”, e dunque poi met√† non vengono espulse e l’altra met√† si perde in mesi di burocrazia che forse si potrebbe evitare, e tutte le due met√† stanno per troppo tempo in condizioni comunque poco umane. Chi ha in gestione il CIE fa quello che pu√≤, ma √® il modo in cui si approccia l’immigrazione in Italia che non funziona.