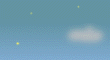Partiamo dalla piazza centrale di Maputo, davanti alla fortezza portoghese e al centro politico del Mozambico.
La prima strada √® larga e piena di automobili; alcune sono scassate in modo incredibile, ma sono molti di pi√Ļ i SUV e i pickup nuovi di zecca. Qui, almeno, avere un fuoristrada ha senso; questo perch√© le strade sono piene di buche gigantesche, anche in piena citt√†. Tranne qualche isolata innovazione realizzata dagli stranieri, le infrastrutture – le strade, i palazzi, l’illuminazione, i marciapiedi – sono quelle realizzate dai portoghesi fino al 1975.
I mozambicani, preso il potere, si sono limitati ad usarle; per molti versi sembra di vivere in uno di quei film apocalittici in cui il mondo √® stato distrutto, e i sopravvissuti cercano di riutilizzare le rovine e le poche infrastrutture rimaste, senza pi√Ļ sapere come costruirle o mantenerle. Per esempio, il meraviglioso giardino botanico in pieno centro ha ormai i vialetti sconnessi, i mosaici spaccati, i canali intasati e le serre con le porte sfondate e il tetto rotto; loro, per√≤, non lo notano nemmeno e lo usano con grande piacere, senza nemmeno tappare le buche… in fondo, basta scavalcarle. Su molti palazzi ci sono addirittura ancora le insegne delle compagnie o delle istituzioni portoghesi che li occupavano prima della Rivoluzione.
Lasciando il centro, si percorre il lungomare: una bella passeggiata pavimentata come nelle citt√† di mare mediterranee, che per√≤ ogni tanto si interrompe e finisce nel vuoto, con pezzi di pietra penzolanti, l√† dove l’acqua l’ha portata via. La spiaggia √® libera, e ogni tanto spuntano alberi e baretti.
A un certo punto spunta una novità: una serie di villette a schiera davanti al mare, costruite dai sudafricani come case di vacanza per ricchi locali e borghesi di Johannesburg. A fianco, un casinò e un costruendo centro commerciale, con i ristoranti e i negozi. Il tutto è ovviamente chiuso e circondato dal filo spinato elettrificato, come le riserve degli elefanti.
Dopo un po’, si svolta verso l’interno; le case sono ancora belle, ma pi√Ļ modeste, come villette di mare nostrane. Qui le vie non hanno nomi ma numeri: via 1523, via 4287… La strada √® sterrata e piena di ragazzini in divisa che tornano da scuola; la scuola √® carina, con un ampio cortile, e piena di murales che proclamano “s√¨ alla lotta all’AIDS”.
Si attraversa una laguna paludosa, e la strada ha sempre pi√Ļ buche; c’√® un prato che potrebbe anche essere un campo, e in fondo si vede un insediamento, un bairro come tanti altri. Si attraversa per qualche centinaio di metri una zona di nessuno, e poi comincia il bairro.
Qui le vie non hanno pi√Ļ niente, n√© nomi, n√© numeri, n√© un percorso definito; sono delle tracce sterrate in mezzo alle quali cresce l’erba, che seguono un percorso tortuoso aggirandosi tra le case. Gi√†, perch√© la pianura sabbiosa, da cui si alza una nuvola di polvere mentre passiamo con il fuoristrada, √® coperta di casupole. Sono regolari, nel senso che anche loro, come tutte le case, sono state costruite e comprate a prezzo di mutui e sacrifici; su alcune c’√® addirittura scritto “Vende-se”. Solo che sono casupole di una decina di metri quadri al massimo, molte anche di meno, costruite sovrapponendo mattoni grigi di cemento preformato, con un tetto di lamiera, talvolta anche di paglia.
Ognuna ha un cortile che in realt√† √® un’aia, perch√© non √® delimitato in alcun modo, nemmeno rispetto alla strada; del resto, ci sono torme di bambini che scorrazzano ovunque, strada compresa, visto che non ci sono veicoli. L’unico mezzo di trasporto per gli abitanti del quartiere √® mezz’ora a piedi verso la strada principale, dove passano gli chapa, i furgoncini privati condivisi, pigiati fino all’inverosimile, che svolgono il trasporto pubblico in Africa, come zanzare impazzite che passano a intervalli irregolari e imprevedibili.
Il nostro autista si ferma, abbranca un bimbo che avr√† cinque anni, lo manda a preavvertire che sta arrivando; il bimbo sparisce tagliando per il nugolo di casette. Noi seguiamo le tracce, piano piano, perch√© ovviamente pi√Ļ di dieci all’ora non si pu√≤ fare; a un certo punto, davanti a una casa uguale e diversa (sono tutte fatte allo stesso modo, ma essendo autocostruite sono anche tutte un po’ diverse) ci fermiamo e scendiamo. E’ la casa del nostro autista. Da tutte le case all’intorno, le persone escono sull’aia; ci guardano come se venissimo da Marte. Entriamo.
La casa √® buia e fatta di due stanzette (il buio √® voluto, per resistere al calore). Il pavimento √® di terra battuta, uguale all’esterno; e ogni angolo √® buono per tenerci qualcosa. Pi√Ļ ancora che la casa in s√©, colpisce ci√≤ che c’√® dentro: non √® che non ci sia niente, ma sono quasi tutte cose che per noi hanno ormai poco senso, dalla bacinella per lavare a mano i vestiti al parallelepipedo di metallo che fa da cucina, con una pentola d’acqua sopra e la brace sotto. Nella camera da letto, per terra, sovrastate da un filo tirato tra le pareti che regge i panni stesi, ci sono le stuoie su cui si dorme; su una di esse c’√® un bimbo di un anno che dorme tranquillo, avvolto in qualche panno. Ce lo mostrano, perch√© √® l’orgoglio della famiglia.
C’√® qualcosa di antico in tutto questo; in parte √® come entrare in un museo, e vedere dal vivo immagini osservate tante volte in fotografia, ma mai di persona. Gli oggetti sono poveri e disparati, accumulati su qualche scaffale di legno. Non c’√® acqua corrente – c’√® un pozzo pi√Ļ in l√† nel quartiere – ma, cosa gi√† rara per il Mozambico, arriva l’elettricit√†, anche se (credo) tramite un generatore da attivare alla bisogna. In tutta la casa, ci sono soltanto due cose del nostro mondo occidentale:
1) Un televisore, di tipo tradizionale e di marca sconosciuta, ma neanche troppo scarso;
2) Varie scatole di latte in polvere Nestlé.
Salutiamo, ripartiamo. Il nostro autista si mette a piangere d’orgoglio: deve avere tipo venticinque anni, e ci racconta di come √® riuscito piano piano a trovare un lavoro, a risparmiare, a comprare il terreno, a costruire la casa, e nel frattempo sposarsi e avere dei figli. (Omette di dirci che ha numerose altre amanti e figli sparsi un po’ ovunque, cosa che per i mozambicani √® del tutto normale, ma si sa che i bianchi hanno questo incomprensibile concetto della fedelt√† coniugale.) Adesso, a forza di risparmiare, ha addirittura potuto comprarsi un Ipod tarocco cinese, l’oggetto pi√Ļ cool del momento, anche se poi ha bisogno che qualcuno gli carichi la musica.
A noi, la povert√† materiale colpisce. Siamo talmente attaccati alle nostre cose che ci sembra impossibile poter vivere senza un divano, senza uno stereo, senza una lavatrice o un forno a microonde; la casa al mare o in montagna, la macchina, il vino e la coca-cola. Eppure, gli africani lo fanno; e poich√© non sono stati (non ancora e non completamente) educati al ciclo del desiderio materiale da appagare ad ogni costo, non sono pi√Ļ infelici di noi. Anzi, la sensazione √® che, tutto sommato, almeno fino a che questo livello di ricchezza materiale non diventa un problema per sopravvivere, per aver da mangiare, per le malattie, vivano come e meglio di noi.
[tags]viaggi, africa, mozambico, maputo, televisore, nestlé, ricchezza[/tags]