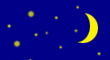Insomma, finisco di lavorare e sono le sette e mezza di sera, che è come dire le nove, e qui l’ora di cena è agli sgoccioli; e non ho tanta fame ma qualcosa mangerei, certo però non il cibo dell’albergo. Così, dopo rapida ricognizione, esco a valutare un paio di posti qui in giro, nel villaggetto di case basse che sta dall’altra parte dello stradone, quella verso l’interno, quella opposta a questa fila infinita di albergoni da spiaggia di tutte le catene del mondo, nessuna esclusa.
Attraverso la strada – è la parte più pericolosa – e seguo il marciapiede, e poi mi infilo in un vicolo sul retro e finisco nell’altra via, una ex stradina di campagna circondata da case basse in cui la gente sopra abita e sotto fa cose, anche se la popolazione principale è dei motorini. E anche guardando non capisci cosa facciano, però la zona è turistica, quindi la metà sono bar e posti da cibo, ma sono tutti deserti.
Alla fine arrivo a quello che mi interessava, ed è deserto; l’ora è tarda, è buio, e non è stagione, e insomma non c’è nessuno tranne loro, la famiglia. Qui tutto è a conduzione familiare, quindi lo è anche questo caffè ristorante, con un menu stampato bene in tre lingue, vietnamita inglese e coreano. Sono una mezza dozzina o più, di cui la mamma è il capo, e un ragazzo ventenne che parla l’inglese molto bene, e una sorella più giovane, e poi qualche parente, e un’infilata di bambini imprecisati. Sono seduti in strada attorno a un tavolo di plastica, e chiacchierano per far passare la serata, come si faceva d’estate anche da noi una volta.
Così, il ragazzo mi fa sedere nel salone che dà sul fuori, ed è deserto; c’è anche un certo tentativo di arredamento, che gli stranieri se no si spaventano, e c’è un bancone da bar, con sopra improbabili ma vere bottiglie di Jack Daniel’s e sciroppi Monin, e pile di calici con sopra la polvere di almeno un paio di generazioni. Il ragazzo mi porge il menu, poi prende due ventilatori grossi come un frigorifero, e me li spara addosso dai due lati, schiacciandomi nella tormenta come un panino.
Io guardo il menu, questo è un caffè, ci sono pochi piatti ma saranno buoni, e prendo un mi quang, che è tipo il pho ma con meno brodo e tiepido, adatto all’estate. Gli chiedo se devo prendere altro, ma mi dice che una cosa basta, che qui le porzioni sono grandi (è così ovunque). Prendo anche una birra, ovviamente la birra vietnamita originale, la Larue, che però ha praticamente lo stesso logo della Tiger, la birra singaporthai che qui passa per un nettare; e gli dico due parole, che vengo dall’Italia, che vado via tra poco.
Così aspetto la mia ciotola, e giochicchio col cellulare, e arriva un bambino: avrà cinque o sei anni. Mi si ferma a fianco e mi fissa, e insomma non è che non siano mai passati occidentali da qui, ma dev’essere comunque uno stupore; e io guardo lui, e quegli occhi asiatici che a noi sembrano sempre strabici, e quello stupore che non sappiamo più di avere dentro. Non c’è gran modo di comunicare, e poi lui va via subito, e arriva il mio piatto.
Ovviamente è ottimo, come tutto il cibo qui, e ha questi spaghetti bianchi e piatti che si gonfiano nel brodo, e delle fettine di manzo, e di contorno un’insalata e la salsa di pesce fortissima che qui si mette su tutto. Me lo mangio tranquillo, anche se il bambino riappare, ma poi si mette a giocare con un’altra bambina, e corrono di qua e di là per la sala e giustamente nessuno ci fa caso, perché questa in fondo è casa loro, e so che dietro c’è la cucina e sopra le camere e la loro vita intera scorre qui, in una strada di periferia di Da Nang, sotto la montagna dell’acqua e dietro uno stradone di turisti che corrono anche loro, ma senza sapere bene dove andare.
I bambini invece vanno avanti e indietro, e alla fine spalancano le porte di legno lucido che danno sul retro, e io mi giro pensando di vedere la cucina, ma in realtà vedo la nonna, cioè, il butsudan della nonna, con una fotografia in bianco e nero di una vecchina vecchissima che non c’è più da tempo e una candela tra le offerte di cibo, e un pugno di riso per non dimenticare. Ma è un frammento di vita altrui che si apre, ed è un bel vedere, certo a chef Barbieri non piacerebbe, e sulla nonna metterebbe un topper, ma siamo qui per fare cena e ringraziare, e per una sera saper di vita vera; e brucerei senz’altro il cellulare, e le recensioni su Google dei locali, e tutti gli aspiranti Masterchef in ogni pizzeria d’Italia, per poter andare fuori anche da noi com’era prima, semplicemente da qualcuno che ti offre le cose di casa perché tu possa essere sazio, e continuare contento la tua vita.
Alla fine prendo il conto, che fa centotremila, e arrotondo a centoventi; sono comunque cinque euro scarsi. Saluto, e non ci rivedremo, però grazie; grazie anche al karaoke cinese stonato della casa poco più avanti, e alla gente su un patio aperto che guarda la televisione, e al buio appena illuminato dei lampioni, in un posto in cui fa caldo, sempre.