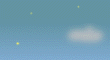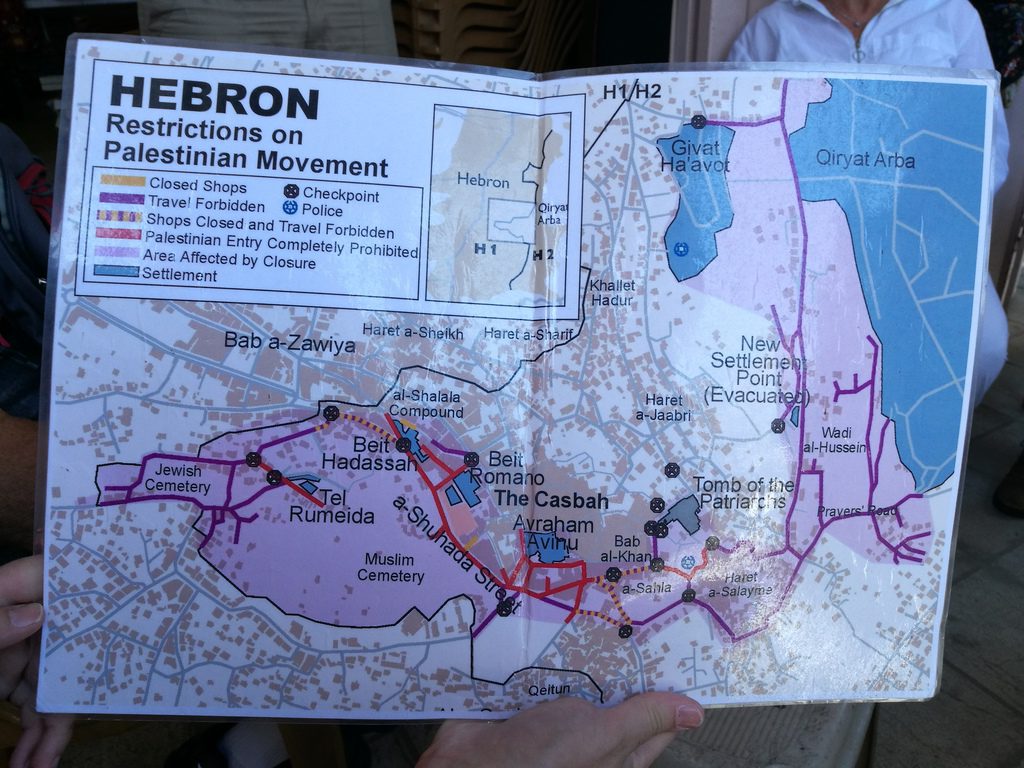A qualcuno piace Londra
Ai turisti italiani piace Londra, nonostante non la conoscano, non la capiscano, non sappiano una mazza di niente della sua storia e della sua anima. Vivono in un territorio a scopettone che comprende la ferrovia da Stansted a Liverpool Street, la City e metà di Westminster. E pure di quello non sanno niente; per esempio, parlano del referendum sulla Brexit e si stupiscono del disastro senza sapere che la caduta di Londra era inevitabile sin da quando, un mese prima, la Pietra di Londra è stata tolta dal suo posto millenario in Cannon Street.
Per esempio, dalle finestre del ricevimento nell’albergone della conferenza, si vede la Westway intasata di macchine; un pezzo di Londra che √® normale per chi ci abita, ma che nessun turista conosce. La Westway racconta di sogni anni ’60 della citt√† dell’automobile, ma anche dei sogni anni ’90 dei Blur, e dall’anno scorso anche dei sogni di due ragazzi italiani emigrati a Londra come tanti. Quattro anni fa, stesso albergo e altra conferenza, la Westway non faceva tanta tristezza, ma era giugno e fuori la vita non sputava pezzi di ghiaccio in faccia.
Comunque, fatte le chiacchiere con le persone che dovevo trovare, alla fine esco; c’√® troppa gente e troppa fame, perch√® per qualche motivo sembra che, quando si tratta di buffet, la maggior parte dei nerd sia un pozzo senza fondo. Voglio comprarmi qualcosa per la colazione di domani, e cos√¨, nonostante la neve, allungo il giro prendendo la strada di Edgware verso il centro; se fossimo in due sarebbe un tentativo di marbolarci, ma anche se l’arco c’√® non ci sei tu, e quindi si limita a essere un tentativo di raggiungere il Tesco Metro che sta a due terzi della strada.
Edgware Road, dal punto di vista architettonico, √® una specie di Lorenteggio ai bordi del centro di Londra; specie sul lato di Bayswater, ci sono palazzoni anni ’70 che non sfigurerebbero in una prima cintura milanese. Dal punto di vista sociale, invece, √® un territorio ufficialmente bilingue, inglese/ISIS; ma solo per qualche isolato, perch√© poi il Londonistan cede il passo al centro vero e proprio, in un rettangolo di confini invisibili che lo contengono nella via trafficata. Che poi, almeno stavolta non √® cos√¨ trafficata: quattro anni fa ero dovuto tornare in albergo a piedi, a causa della strada bloccata dai cortei di algerini che festeggiavano la qualificazione al Mondiale.
Peccato solo che il Tesco Metro sia chiuso: uno scandalo, pare che chiudano addirittura mezza giornata la settimana, la domenica dopo le cinque (gli Express, invece, sono in buona parte aperti 24 ore su 24). Sarebbe bello addentrarsi in Hyde Park nella tormenta di neve, ma √® buio e potrei anche rimanerci congelato dentro, e cos√¨ taglio dentro il labirinto georgiano dei palazzi ultrasignorili per tornare al mio albergo, che sta altrettanto signorilmente oltre Paddington. Attraverso uno scenario spettrale fatto di BMW X4 coperte di neve, aggiro la chiesa di Hyde Park Crescent dove bambini benissimo fanno non so cosa; non sono le mie zone, io di solito bazzico East London (anche se pure l√¨ ormai bisogna sparare a vista alla gentrificazione), l√¨ al massimo c’√® la chiesa di San Botulfo fuori Aldgate, che tanto √® sempre chiusa perch√® vanno tutti alla non lontana moschea.
Alla fine, camminando, arrivo da Micky’s: che √® il fish & chips del quartiere, naturalmente venti metri dopo aver superato un nuovo confine invisibile che porta verso Praed Street e la confusione umana della stazione di Paddington. Micky’s rocks, anche perch√© sta fisicamente sopra alla Circle Line, sul trincerone costruito centocinquant’anni fa, e quindi ogni due minuti trema tutto. Micky’s non √® fighetto come Poppies, che non a caso sta nella parte gentrificata di East London o in alternativa a Camden (Camden! finti alternativi sin dagli anni ’80). Micky’s √® un fish & chips grezzo, vero, operaio, originale e veracemente britannico, a partire dal fatto che √® gestito da una famiglia di turchi.
E per√≤ entro, e per dieci sterline mi faccio dare un merluzzo fritto benissimo, competitivo con quello di Poppies: la pastella √® pi√Ļ unta, ma il pesce √® perfetto, ancora morbido dentro. Certo, il posto √® scrauso, del resto siamo in Inghilterra e pure la regina ha la moquette nel cesso; son sottigliezze. Poi dietro di me entrano tre francesi che riescono a ordinare “chick√©n burg√®re” e Fanta. In un fish & chips. Volevo pisciargli io nel piatto, ma son sicuro che l’abbiano fatto i turchi gi√Ļ in cucina.
Ma chi se ne importa! Adesso ho in corpo tutto l’olio del mare del Nord, a tenermi caldo nell’ultimo tratto a piedi fino all’albergo. Non so se avr√≤ ancora tempo di fare un giretto, nei prossimi giorni; nel caso, potrei anche non raccontarvelo.