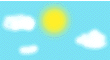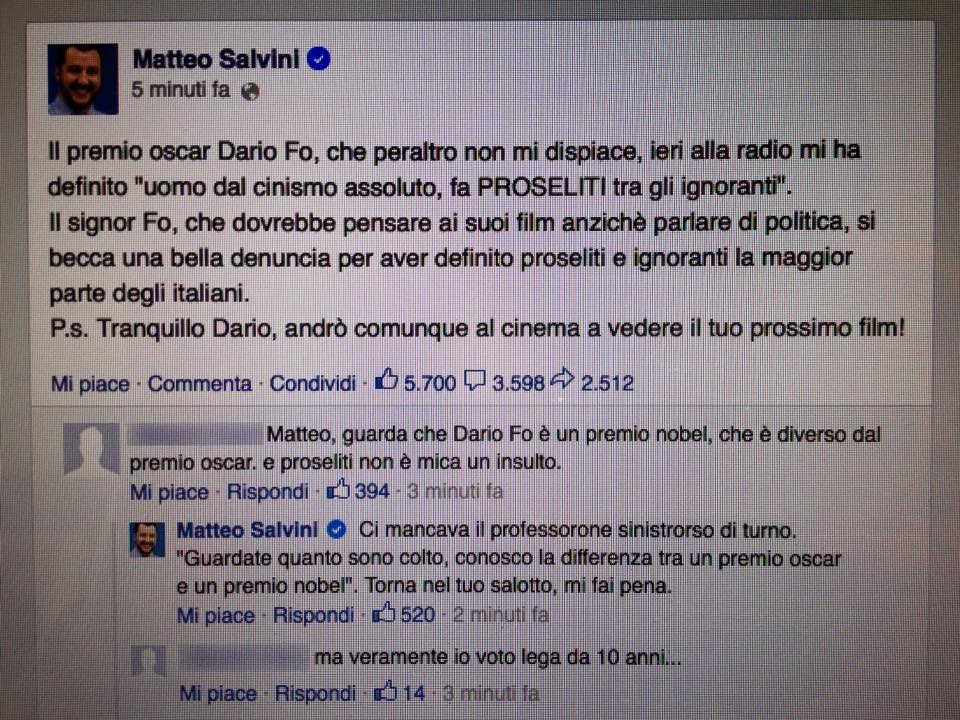Sul MOI facciamo chiarezza
Oggi torna sui giornali l’argomento dell’ex MOI, occupato da pi√Ļ di tre anni da centinaia di immigrati, e di come liberarlo dall’occupazione, che – al di l√† degli alti e bassi, dei reati pi√Ļ o meno gravi che l√¨ si sono compiuti e delle esperienze di comunit√† che vi si sono costruite – non pu√≤ certo durare in eterno, anche perch√© la propriet√† ha ottenuto da tempo dalla magistratura un ordine di sgombero la cui esecuzione, finora sospesa per motivi di ordine pubblico, non pu√≤ essere rinviata all’infinito.
L’argomento √® delicato e divide trasversalmente le idee e le coscienze; divide anche il Movimento 5 Stelle, tanto che in consiglio comunale io e Chiara ci esprimemmo diversamente, e che nel programma elettorale si √® stati ben attenti a non essere troppo chiari su ci√≤ che si vuole fare, usando gli stessi giri di parole che ritrovo negli articoli di oggi.
Difatti, sul fatto che l’occupazione vada superata siamo tutti d’accordo, ma ci si divide sul come: dando una casa o una sistemazione agli occupanti, al di l√† del fatto che ne abbiano o meno diritto, pur di scongiurarne le proteste; oppure agendo se necessario con la forza per allontanarli, ma senza concedere loro un trattamento diverso da quello di chiunque altro?
Il problema di fondo, infatti, è che gli occupanti appartengono sostanzialmente a queste quattro categorie:
1) profughi che hanno completato il ciclo di accoglienza, sono gi√† stati mantenuti dallo Stato per un paio d’anni e poi sono rimasti in Italia regolarmente ma senza lavoro e sostegno, lasciati in mezzo a una strada (parecchi dei primi occupanti del MOI erano ex occupanti di via Asti e prima della Clinica San Paolo);
2) finti profughi, ovvero richiedenti asilo la cui domanda è stata bocciata e ora sono in Italia come clandestini;
3) clandestini “semplici”, ossia persone entrate in Italia irregolarmente o il cui permesso di soggiorno √® scaduto, e che non sono mai state richiedenti asilo;
4) immigrati regolari rimasti senza lavoro e senza mezzi di sussistenza (che, presumibilmente, diventeranno clandestini alla prossima scadenza del permesso di soggiorno).
Nessuna di queste quattro categorie avrebbe diritto ad alcun sostegno da parte dello Stato o del Comune, a parte forse qualcuno delle ultime due se si scoprisse che ha i requisiti per essere un profugo senza aver mai richiesto tale status (ma è un caso raro, perché chi può fa subito la domanda).
C’√®, per√≤, un primo “ma”. La maggioranza uscente decise, nel dicembre 2013, di concedere anche agli occupanti abusivi la residenza a Torino, istituendo l’indirizzo fittizio di “via della Casa Comunale 3”. Quella fu una delle occasioni in cui io e Chiara ci dividemmo; lei era favorevole, io astenuto (potete leggere qui i riassunti dei nostri interventi in aula e anche il mio post dell’epoca).
La conseguenza pi√Ļ importante di questa decisione √® che nel prossimo inverno centinaia di occupanti del MOI (un anno fa risultavano essere per l’anagrafe oltre 700) matureranno tre anni di residenza a Torino, e come tali avranno il diritto di ottenere una casa popolare, probabilmente passando in cima a tutte le graduatorie visto il loro stato di nullatenenti assoluti (tra l’altro, la legge regionale esclude dalle case popolari chi occupa abusivamente una casa popolare, ma non chi occupa abusivamente altri tipi di alloggi). E dato che a Torino sono disponibili 400-500 alloggi ATC l’anno, se le cose rimarranno cos√¨, √® probabile che per un anno non ci siano case per nessuno se non per gli ex occupanti del MOI.
All’epoca si disse anche che le regole regionali sarebbero state riviste per “diluire” questo flusso, evitando una paralisi del sistema che avrebbe facilmente portato tensioni sociali; non so se sia stato fatto o se intendano farlo ora, viste anche le recenti dichiarazioni di Fassino sulla doppia graduatoria. Questo, per√≤, rende ancora pi√Ļ urgente mettere mano alla situazione del MOI.
Soluzioni facili non ce ne sono; gli articoli parlano di un modello simile a quello usato per Lungo Stura Lazio. L√¨, per√≤, la situazione era diversa; non si parlava di occupanti abusivi organizzati di edifici altrui, ma di persone che si erano accampate dove e come potevano; i clandestini erano pochissimi, e molti invece erano cittadini italiani o europei, anche con un lavoro per quanto misero e precario, con diritti gi√† maturati e con pieno diritto a rimanere in Italia; inoltre, c’erano cinque milioni di euro messi a disposizione dallo Stato centrale. Qui, se non arriva uno stanziamento specifico da parte del governo, soldi non ce ne saranno, a meno che il Comune non li reperisca di suo, dal proprio bilancio, togliendoli a qualcos’altro.
Si capisce che il pericolo di uno sgombero senza paracadute sia grave: cosa farebbero centinaia di persone senza nulla da perdere, una volta allontanate da l√¨, perdipi√Ļ assistite da centri sociali e organizzazioni pro migranti? Occuperebbero qualcos’altro, manifesterebbero in blocco per il centro? Da qualche parte dovranno pur andare.
D’altra parte, anche stabilire il principio che chi occupa in blocco prima o poi sar√† sistemato, al di l√† dei propri diritti, √® molto pericoloso. A quel punto cosa impedirebbe a una parte delle centinaia di migliaia di clandestini o di profughi che vivono in Italia di occupare in blocco edifici fatiscenti per farsi sistemare dal Comune di Torino? Chi convincerebbe i profughi che hanno terminato il ciclo di accoglienza, di solito senza conquistarsi alcuna sistemazione o autonomia economica, ad uscire pacificamente e arrangiarsi? E a cosa servirebbe sgomberare il MOI con tanta fatica, col rischio che un mese dopo ci siano altre 800 persone accampate l√¨ in attesa di farsi sistemare?
Qualunque scelta si faccia i problemi sono grandi, e questo √® innegabile. D’altra parte, √® anche bene che le scelte siano chiare; e per ora non lo sono. Non si √® capito, infatti, quale delle due strade voglia percorrere l’amministrazione; se vuole fare un censimento per aiutare solo quelli che ne hanno diritto in quanto profughi non ancora accolti, gi√† sappiamo che saranno una sparuta minoranza e che rester√† il problema di tutti gli altri; se invece vuole sistemare tutti gli occupanti, o anche solo inserire nelle case popolari quella grande maggioranza degli occupanti che ha avuto la residenza, perch√© “siamo tutti esseri umani, la casa √® un diritto di tutti e sogniamo un mondo senza frontiere”, come sentivo ripetermi dagli esponenti del M5S che ora si occupano della materia, allora vorrei capire come potr√† spiegare la cosa alle migliaia di famiglie italiane e straniere che vengono sfrattate ogni anno e che finiscono in mezzo a una strada o si arrangiano come possono, aspettando per anni una casa senza occupare alcunch√©.