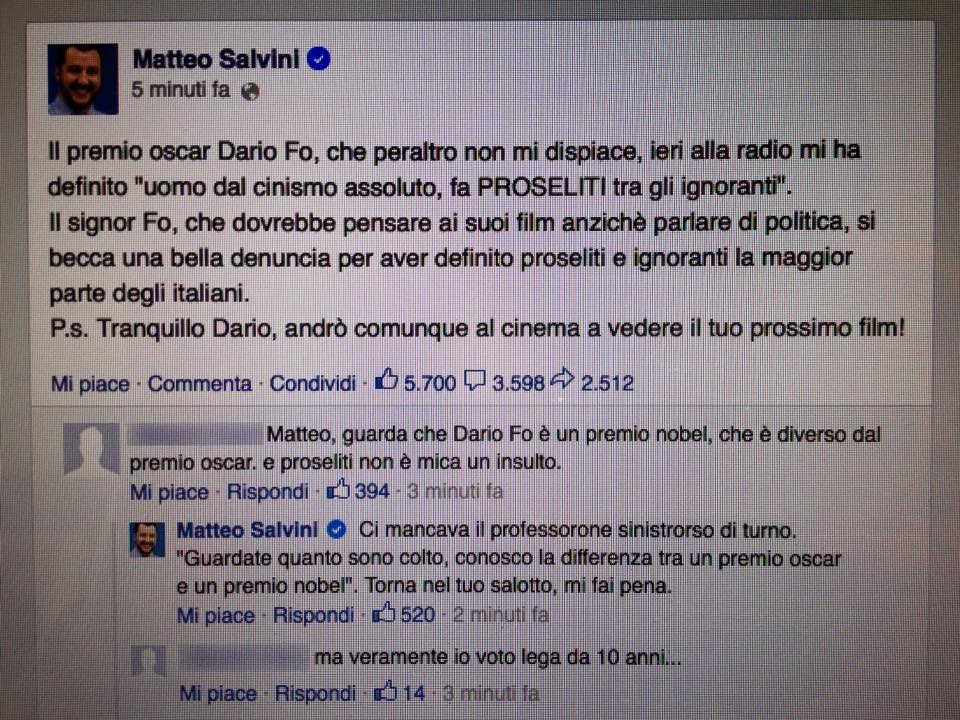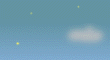Uno degli argomenti più dibattuti in rete, quando si parla di immigrazione, è questo: gli immigrati sono un costo o una ricchezza? I giornali ne parlano spesso, e ne parlano malissimo; di solito si limitano a un concetto strettamente economico di “ricchezza” (lo farò anch’io in questo articolo, rimandando altre riflessioni al futuro) e sparano un titolone con una cifra che faccia impressione, positiva o negativa a seconda del pregiudizio che il giornale ha rispetto al fenomeno.
Repubblica, per esempio, definisce gli immigrati “un tesoro da 123 miliardi di euro”; detto così, sembra che siano soldi che gli immigrati mettono di tasca loro, ma in realtà si tratta semplicemente della fetta di PIL corrispondente in proporzione al numero di lavoratori immigrati rispetto al totale dei lavoratori in Italia (l’8,8%). Per dire che questa ricchezza è generata dagli immigrati, bisogna dare per scontato che in loro assenza non ci sarebbe altro modo di produrla, ad esempio impiegando al loro posto i disoccupati italiani, oppure migliorando la produttività degli altri lavoratori; e questo può essere o non essere vero a seconda di tanti fattori, a partire dal tipo di produzione e di competenze richieste.
Ancora peggio è Il Giornale, una vera fabbrica di cifre usate male, grazie a una costante manipolazione dei termini. Sia quando espone cifre corrette, come il miliardo di euro annuo abbondante che ci costa l’accoglienza dei profughi, sia quando fa confronti che non stanno nè in cielo nè in terra, come quello tra il costo mensile (peraltro abbastanza gonfiato) dell’accoglienza di un profugo e lo stipendio mensile di un poliziotto, Il Giornale non usa la parola “profugo” o “sbarcato” o “rifugiato” ma parla genericamente di “immigrato”. Eppure queste spese si riferiscono solo alle decine di migliaia di profughi attualmente ospitati nel nostro sistema di accoglienza, e non a tutti i circa cinque milioni di immigrati (più i clandestini, presunti essere tra 500.000 e un milione) attualmente presenti in Italia.
Il discorso, infatti, è ben diverso se parliamo degli immigrati regolari, quelli che entrano e rimangono in Italia con un permesso di soggiorno e con un lavoro, o se parliamo dei poveretti appena sbarcati a Lampedusa, sia che siano veri rifugiati che hanno perso tutto, sia che siano persone in cerca di lavoro e benessere.
Per quanto riguarda l’immigrazione in generale, troverete citato ovunque il rapporto di una certa Fondazione Moressa di Venezia, che trovate esposto qui alle pagine 11 e 12, e che conclude che il conto tra quanto gli immigrati versano allo Stato e quanto ricevono in servizi sarebbe in attivo di 3,9 miliardi di euro: 16,5 miliardi di entrate e 12,6 di uscite.
Ora, io vi prego di leggere bene in quel documento la tabellina e la spiegazione, perché qualche dubbio sulla sensatezza di questo calcolo ce l’ho. In particolare, più della metà delle entrate sono i contributi previdenziali, eppure in uscita la voce per i trattamenti previdenziali non compare affatto; a parte che ormai nella prima generazione di immigrati ci sono anche i pensionati, ma tra venti o trent’anni poi queste pensioni andranno pur pagate, quindi un qualcosa andrà pure accantonato.
Poi si arrampicano sugli specchi: ti dicono che la sanità costa molto, ma gli immigrati la usano meno della media perché sono giovani, quindi non puoi imputargliela appieno; poi però ti dicono che, essendo giovani, usano la scuola più della media, ma comunque i costi della scuola sono fissi perché sono gli stipendi degli insegnanti, quindi non puoi imputarli a loro. E nella sanità gli stipendi non ci sono? E poi anche in settori come casa e servizi sociali gli stranieri beneficiano dei servizi in maniera ben più alta della media; vi raccomando di dare un’occhiata all’elenco dei beneficiari dei contributi per l’affitto del Comune di Torino per farvi un’idea da soli.
Anche altre voci di spesa sono palesemente sottostimate: per esempio la spesa per la gestione dei fenomeni migratori (“Ministero dell’Interno”) è stimata in un miliardo di euro, ma noi sappiamo che è già superiore solo la spesa per l’accoglienza dei profughi esclusi i costi di salvataggio, trasporto e gestione, senza nemmeno cominciare a parlare di tutti gli altri immigrati.
Infine, un altro grosso errore: dal lato delle spese, l’elenco è chiaramente incompleto. Difatti, all’attivo viene messo l’intero gettito Irpef dei lavoratori immigrati, nonché una minuzia di altre tasse (persino le tasse sul presunto gioco d’azzardo da parte degli immigrati, o sulla benzina che probabilmente comprano…), ma come spese vengono contate solo alcune delle voci pagate con le entrate fiscali nazionali dei cittadini: sanità , scuola, servizi sociali, casa, giustizia. E i trasporti? Le strade? La polizia? L’ambiente? La cultura? Gli immigrati usufruiscono di tutti i servizi pubblici, come tutti gli altri cittadini. La spesa pubblica italiana è di 835 miliardi, se gli immigrati sono quasi il 10% della popolazione la loro quota potrebbe arrivare fino a 80 miliardi, altro che 12,6.
E in tutto questo non abbiamo ancora considerato un altro grosso fattore: loro stessi stimano in 5,5 miliardi (qui, al fondo di pagina 3) il valore delle rimesse inviate ogni anno dagli immigrati al loro Paese, soldi che non sono una spesa dello Stato, ma che comunque lasciano l’economia italiana e vanno ad alimentare quella di altre nazioni, e che però nel conto non compaiono.
Allora, capite che questo calcolo è talmente complesso, e talmente influenzato dal risultato che si vuole ottenere, che lascia un po’ il tempo che trova; peraltro, stante che il bilancio italiano è in perenne deficit e che abbiamo un’ampia tendenza all’assistenzialismo, sospetto che il conto sarebbe negativo anche per buona parte degli italiani.
Credo quindi che non abbia molto senso discutere se “gli immigrati” portano ricchezza oppure vivono alle spalle degli italiani; è un tipo di ragionamento strumentale sin dal principio, che viene fatto solo per dare una pretesa di scientificità ai propri pregiudizi positivi o negativi sull’immigrazione. Perché, vedete, “gli immigrati” o “gli italiani” non sono categorie sensate; bisogna capire cosa fa ogni persona.
Basta un po’ di buon senso per capire infatti che l’immigrato che arriva qui, rispetta la legge, lavora, paga le tasse è una ricchezza per tutti; mentre l’immigrato che arriva qui e non lavora, trovandosi a sopravvivere di espedienti ai margini della società o peggio a rubare o spacciare o prostituirsi per vivere, non è una ricchezza ma un danno.
E’ proprio per questo che tutti gli stati moderni, almeno dall’età industriale, non lasciano entrare chiunque, ma adottano politiche di gestione dei flussi: decidono quante persone possono essere accolte dall’economia e che qualifiche devono avere, fanno entrare quelle e rimandano indietro gli altri. Il primo strumento di integrazione, difatti, non è il sindaco che festeggia il Ramadan con te per mettere la foto sui giornali, e nemmeno l’accoglienza in albergo pagata dalla collettività , ma è il lavoro che ti trovi e che ti permette di mantenerti e di sistemare te e la tua famiglia; senza lavoro non c’è integrazione.
Per questo io sono basito da tutti quelli che dicono che noi dobbiamo accogliere a braccia aperte tutti quelli che si presentano oggi alle nostre frontiere, perché un secolo fa noi siamo stati accolti negli Stati Uniti e altrove. Gli Stati Uniti hanno accolto quasi tutti per un periodo ben definito, alla fine dell’Ottocento, in cui avevano un intero continente da popolare e colonizzare; una situazione molto particolare, certo non quella dell’Italia di oggi. Anche loro facevano comunque una selezione sulla capacità di lavorare, rimandando indietro per esempio i disabili, e nel Novecento ben presto introdussero un sistema di quote e progressivamente chiusero le frontiere; e gli italiani che entrarono là , lo fecero quasi tutti regolarmente, con un visto valido e dopo essere stati identificati e schedati. Oggi, negli Stati Uniti, senza qualifiche si entra a numero chiuso con una lotteria; in Australia nemmeno così, ma si entra, dopo i trent’anni, praticamente solo se si fa parte di una serie ben precisa di professioni di cui hanno bisogno. Se ti presenti alla frontiera senza il visto, ti fermano (oddio!), ti mettono in una cella (oddio!!!), e ti reimbarcano a tue spese sul primo aereo per il tuo Paese (oddio!!!!! tutte cose che qui sono bollate come razzismo).
I rifugiati, quelli veri, sono un caso particolare; sono persone che non hanno necessariamente prospettive di integrarsi nella nostra economia, e che quindi potrebbero pesare sul nostro sistema di welfare a lungo, ma che accogliamo per civiltà e solidarietà . Gli altri, i migranti economici, quando sono entrati in questi anni con un visto e hanno trovato un lavoro, hanno dato e stanno dando il loro contributo al benessere degli italiani e sono i benvenuti.
Quelli però che non rientrano in una stima dei lavoratori che ragionevolmente possiamo assorbire, quelli che non troveranno un lavoro e resteranno in mezzo a una strada, non saranno una ricchezza, ma un problema per tutti. E allora trovo giusto che anche l’Italia decida ogni anno quanti migranti economici accogliere, che riceva le domande già dai Paesi di origine e gli conceda il visto prima di partire, in modo che i prescelti possano venire qui in aereo e non rischiando la vita in mare, e possano arrivare e lavorare e prosperare insieme a noi, magari nell’ottica di trasferire poi denaro e conoscenza nel Paese di origine per accelerarne lo sviluppo. Per gli altri, mi spiace: senza razzismo, senza cattiveria, ma oggettivamente il posto non c’è.