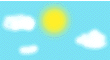Un ego che fa provincia
Ultimamente pare diventato di moda: a chiunque tu chieda cosa fare per salvare l’Italia, tra le prime cinque voci c’è l’abolizione delle province. Effettivamente, forse potremmo cavarcela con un po’ meno burocrazia… In realtà , si tratta di suddivisioni amministrative, nate per organizzare meglio la struttura burocratico-aziendale dello Stato. Come tali, “servono” o “non servono” a seconda di cosa gli si dà da fare, ragion per cui sarebbe probabilmente più produttivo andare ad esaminare le loro competenze – dalle strade all’edilizia scolastica – e capire se e come possono essere trasferite altrove in modo più efficiente, considerando che comunque qualcuno se ne dovrà occupare.
Purtroppo, però, raramente la questione viene affrontata in termini pratici; sulla discussione prevale sempre un altro aspetto, quello dell’ego collettivo delle comunità interessate, con il desiderio di vedere la propria città riconosciuta a livello nazionale, e con la conseguente creazione di burocrazia, posti di lavoro pubblici, infrastrutture di collegamento.
Del resto, il concetto stesso di provincia non è che l’evoluzione delle suddivisioni feudali in vigore fino all’era della rivoluzione industriale, divenute progressivamente inadatte con l’affermarsi della borghesia e l’incremento del peso centrale degli stati nazionali. In origine infatti non era certo questione di elezioni provinciali, ma semplicemente di governatori o prefetti inviati dal governo centrale per gestire un determinato territorio.
Fu l’inventore dello Stato moderno, Napoleone, a imporne la definitiva affermazione; e così, dopo la Restaurazione, lo Stato sabaudo si divise anch’esso sul modello francese, in dipartimenti (l’equivalente delle odierne regioni) a loro volta suddivisi in province. Erano province decisamente più piccole delle attuali, tanto è vero che per un territorio comprendente un sesto dell’Italia più la Savoia c’erano ben 49 province, a loro volta ulteriormente suddivise in centinaia di mandamenti formati da una manciata di villaggi. Non dissimile era la situazione negli altri regni pre-unitari.
Nel 1859, in piena seconda guerra d’indipendenza e con la prospettiva di annettersi gran parte dell’Italia, il ministro dell’Interno Urbano Rattazzi si rese conto che andare avanti con suddivisioni così piccole avrebbe implicato sprechi e difficoltà ; e così, diede il via a una radicale ristrutturazione, basata proprio sul principio di “eliminare le province” spostando i poteri ai dipartimenti. Questa riforma, purtroppo, fu concepita con un piccolo problema di marketing: difatti si scelse di rinominare i nuovi dipartimenti in province, col risultato di far sembrare a 39 città di aver semplicemente perso lo status di capoluogo provinciale e di essere state “annesse” dalle rimanenti dieci.
Apriti cielo! Da Mortara a Biella, da Vercelli a Casale, da Asti a Savona, tutte le città degradate la presero maluccio. I più incazzosi, manco a dirlo, furono i genovesi dell’Oltregiogo: non solo gli avevano soppresso la provincia di Novi, ma, nonostante fossero da sempre stati parte della Repubblica di Genova, li avevano addirittura annessi ad Alessandria! Fu quello il momento in cui tutti i comuni della zona, in quello che De André avrebbe definito un atto di vibrante protesta, aggiunsero “Ligure” al proprio nome; e sono ancora incazzati adesso, tanto che il profluvio di pagine relative alla storia delle province italiane, in rete e su Wikipedia, viene quasi tutto da quei posti lì; e non ce n’è una che si dimentichi di buttar lì maliziosamente che Rattazzi era di Alessandria.
Tuttavia, questi episodi dimostrano come i confini amministrativi, anche quelli interni alla nazione, possano avere conseguenze significative sull’evoluzione storica dei territori. Per esempio, a tutti ormai sembra pacifico che la Lomellina sia un territorio lombardo, gravitante su Pavia; e invece, fino al decreto Rattazzi era un pezzo del dipartimento di Novara, tanto che non fu annesso al Piemonte in quegli anni come il resto dell’attuale Lombardia, ma faceva già parte del regno sabaudo sin dal 1707.
Oppure prendiamo Ascoli e Fermo, che al momento dell’Unità erano entrambi capoluoghi di provincia dello Stato Pontificio, entrambi con circa ventimila abitanti; per qualche misterioso motivo, nel 1860 lo Stato sabaudo decise che solo il primo sarebbe rimasto capoluogo, mentre il secondo sarebbe stato annesso dagli odiati vicini. Come conseguenza, partendo da condizioni simili – anzi Fermo è più vicina al mare e alle linee di grande comunicazione -, Ascoli e cintura ha oggi quasi il doppio degli abitanti di Fermo: quanto di questo sarà un effetto del ruolo di capoluogo? (Comunque dopo centocinquant’anni i fermani ce l’hanno fatta, e dal 2004 hanno di nuovo la provincia.)
Dopo le guerre d’indipendenza – a territorio sostanzialmente simile all’odierno – le province erano 69; oggi sono 110, cioè quasi il doppio. Certo sono aumentati anche gli abitanti, ma vi è indubbiamente una tendenza a un costante aumento del numero delle province, in seguito alle pressioni di questa o quella città aspirante capoluogo; negli ultimi anni poi è diventata una valanga (toh, divertitevi). In particolare in Meridione, dove la burocrazia pubblica è l’unica industria esistente, ogni buco di quattro case aspira ai suoi bravi uffici provinciali nuovi di zecca; tranne che in Sardegna, dove essendo regione autonoma ci sono già riusciti.
E quindi, forse è l’ora di tirar fuori un nuovo Rattazzi e di vietare ulteriori province, cercando poi di capire se le funzioni delle attuali non possano essere girate ad enti già esistenti, risparmiandoci qualche ciclo elettorale e un bel po’ di spese correnti; o perlomeno, dopo centocinquant’anni si potrebbe rimettere mano a un po’ di sani accorpamenti. Attenti, comaschi e verbani: Maroni è di Varese!
[tags]province, abolizione, burocrazia, rattazzi, novi ligure libera, lomellina piemontese, fermo provincia, collegno provincia[/tags]