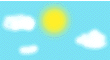Oggi – cio√® ieri, per voi che leggete (cio√® sarebbe oggi, ma io scrivo stasera e metto il post in pubblicazione per domani mattina, che per√≤ per voi sar√† ancora oggi, ma solo se sarete svegli molto presto, quindi sono quasi sicuro che sar√† domani e quindi parliamo di ieri) dicevo, oggi sono andato a Otaru, secondo l’ufficio del turismo “the romantic city of Hokkaido”, nella realt√† un magico incontro tra il porto industriale di La Spezia e le periferie di Los Angeles. E’ stato comunque piacevole – la cosa migliore √® la linea ferroviaria che corre chiusa per alcuni chilometri tra le montagne e la spiaggia, anche se mi sembra di averne gi√† viste del genere nella mia vita – ma ve lo racconter√≤ poi, perch√© stasera parliamo di cibo.
Sapevo infatti che, finita la conferenza, avrei rischiato di morire di fame: la mia riluttanza ad andare al ristorante da solo √® notevole, per cui quando sono all’estero vivo di fast food, di supermercati o comunque di posti dove posso prendere del cibo e mangiarmelo al volo per i fatti miei. Soffro comunque il complesso del commesso, per cui se la lingua del posto non √® l’inglese devo anche vincere la resistenza secondo cui, entrato nel negozio, alla mia incapacit√† di comunicare nella lingua locale verr√† opposta una sonora risata, dopodich√© tutti i presenti nel negozio si fermeranno per gridarmi in coro “ah-ha”, e poi spunter√† d’improvviso la mia maestra delle elementari per cacciarmi a bacchettate nell’angolo in castigo.
Immaginate quindi come sia per me l’idea di andare a chiedere del cibo in un posto dove non solo non capisco una parola della lingua (beh, tre o quattro le capisco, ma non di pi√Ļ), ma dove non so nemmeno pronunciare i nomi dei piatti, anzi nemmeno i numeri (cio√® quelli li saprei, ma poi ho paura di sbagliare e allora non li dico).
Ieri sera, per dire, volevo provare il ramen: Sapporo √® famosa per avere una “via del ramen” piena dei classici negozietti, quelli che si vedono in manga come Ranma 1/2 o Naruto, dove il protagonista si siede su uno sgabello al bancone e ordina ramen in quantit√† (per i non esperti: il ramen √® spaghetti + brodo + eventuale altro materiale edibile sparso nel brodo). Cos√¨ sono arrivato alla via, e mi sono reso conto che √® proprio come nei fumetti: anzi, ci deve essere una legge che vieta di vendere ramen se la superficie del locale √® superiore a tre metri quadri. In pratica, bisogna ordinatamente mettersi in fila – qui c’√® una fila per tutto, altro che Londra – e attendere il turno, poi negoziare il posto al bancone o in un microtavolino, poi ordinare – e non c’era mezza riga di menu in inglese. Cos√¨, gi√† intontito dalla folla, ho lasciato perdere: ho risolto comprandomi un sacchetto di patatine al 7-Eleven.
(La folla √® un altro problema: io non ho mai avuto paura della folla, ma qui si esagera; in una serata qualsiasi di un giorno feriale, il marciapiede era rigonfio di centinaia di giovani, alcuni punk, alcuni in kimono, tutti in giro per la citt√†. Qui tutti si muovono istintivamente in maniera ordinata, alla stessa velocit√†, procedendo esattamente diritto, il che permette di evitare scontri; per noi, abituati a sbracciarci e cambiare direzione di botto, √® un delirio. Peraltro ho detto a un amico “che folla, qui!” e lui, mentre sincronizzava perfettamente il passo con la persona davanti e quella dietro per evitare l’urto, ha risposto “ma no, qui non c’√® nessuno, non hai visto Shibuya!” Domani vedo Shibuya e vi dico.)
Comunque, anche il supermercato √® un problema: perch√© c’√® un intero supermercato pieno di roba da mangiare e da bere che sembra la nostra, ma non lo √®. Qui ogni assaggio √® una sorpresa: le normali convenzioni di associazione tra colore, forma, consistenza e gusto sono tutte definitivamente sospese. Insomma, ci sono scaffali e scaffali di cose, ma quasi nessuna ha un equivalente in occidente; ho trovato giusto in un angolino delle patatine simil-Pringles; come snack dolci, ci sono gli Snickers e un po’ di cioccolato, ma nulla d’altro; ci sono brioche e simili, per√≤ spesso hanno i ripieni pi√Ļ strani; gli snack salati sono un delirio, tipo crackers che sanno di fumo, bastoncini che sanno di pesce, palline che sembrano caramelle ma sanno di qualcosa tipo maiale in agrodolce, o chiss√† cosa. Anche tra le bevande, la Coca Cola sta dimenticata in un angolino (mai vista una cosa del genere); gli scaffali sono pieni di decine di tipi di t√© e succhi di frutta, oppure di caff√© e caffelatte in lattina (non ho ancora osato).
Alla fine, oggi mi sono vergognato di me stesso e ho deciso: basta, oggi compro del cibo serio. Ho passato la mattinata sotto la pioggia, con in pi√Ļ un vento di direzione casuale che tirava l’ombrello dove voleva lui. Poi, all’ora di pranzo, volevo andare a prendere il treno per Otaru: ho quindi pensato di mangiare alla stazione. Sapevo che nel sotterraneo di uno dei tre enormi centri commerciali che costituiscono la stazione (dieci piani l’uno) c’era una food court; per√≤ era gi√† tardi, e non volevo perdere tempo, per cui ho deciso di mangiare dai chioschetti davanti all’ingresso dei binari. La scelta era quindi limitata: c’era un bar che faceva curry bianco e altra roba troppo raffinata, una panetteria/pasticceria e un caff√© con roba fritta.
Ho girato in tondo per dieci minuti, poi ho detto: basta, adesso proviamo. Il caffé-fritto aveva i fritti in vetrina vicino alla cassa: ho pensato che, mal che andasse, avrei indicato.
Effettivamente la cassiera, molto gentile, non parlava nemmeno mezza parola d’inglese, nemmeno “thank you”. Per√≤, con la forza del dito indice, sono riuscito a ottenere un pezzo di pesce fritto e uno spiedino di palle di pur√©, o almeno sembravano delle palle di pur√© di media grandezza immerse nella pastella, poi infilzate nello spiedino e fritte, per√≤ c’era un retrogusto di qualcosa che sembrava tipo acetone o carcassa di animale, comunque quasi buono; il pesce era eccellente. Sicuramente ho commesso svariate scortesie, anche se non ho contato il resto; per esempio credo di aver portato dentro l’ombrello, e mi sa che non si fa; sono riuscito a non soffiarmi il naso, ma una volta ho starnutito e un’altra mi sono grattato la testa, e quelli vicino a me si sono allontanati. E poi ovviamente io ho usato la salviettina per pulirmi le mani dopo aver mangiato e non prima.
Comunque, galvanizzato dal successo, sono entrato nella pasticceria self service. In pratica √® un self service – questo era piccolo, ma poi ne ho visto un altro enorme al piano di sotto, proprio come fosse il Brek – dove tu ti addentri con vassoio e pinzette, e lo carichi di dolci di ogni genere: brioche, pezzi di torta, cioccolato, palline ripiene… Questo aveva anche (sempre da prendere con le pinzette) pezzi di pizza e patatine: a saperlo prima… Poi arrivi alla cassa, porgi il vassoio, e qui…
…ecco, ho scoperto un’altra cosa che noi occidentali ignoriamo: questa √® la civilt√† dell’imballaggio. Qualsiasi cosa √® imballata singolarmente, poi messa in un contenitore che viene imballato, chiuso e messo in un sacchetto – anche se stai comprando degli stuzzicadenti. Due giorni fa ho comprato dei biscottini, tipo quelli americani ma pi√Ļ piccoli: mi √® stato dato il sacchetto, con dentro la scatola di alluminio stampato, che dentro aveva il vassoietto di plastica, che dentro aveva venti piccoli imballaggi di alluminio stampato con un biscotto ciascuno. Oppure, ho preso caffelatte e muffin a uno Starbucks: mi hanno dato un sacchetto di carta, dentro il quale hanno messo una base di cartone rigido con un buco tondo, in cui hanno infilato il contenitore di cartone spesso del caffelatte, tappato con una palettina di plastica che permette anche di girare la schiuma; a fianco, c’era un buco quadrato in cui hanno infilato il muffin, avvolto in un sacchettino di carta, e poi hanno ancora aggiunto un pacchettino di plastica contenente la salviettina umidificata. Fanno otto pezzi diversi di materiale, per caffelatte e muffin; l’Amazzonia ringrazia, ma loro sono ossessionati dall’igiene.
Anche nella pasticceria mi hanno avvolto ciascun pezzo in un sacchettino, poi mettendo il tutto in un sacchetto; cos√¨ sono uscito, ho preso anche da bere alla macchinetta, e poi mi sono seduto su una panchina a mangiare, e solo l√¨ ho realizzato che ero l’unico in tutta la stazione a mangiare sulla panchina. Ho il forte sospetto che non si faccia, anzi, a dire il vero non ho mai visto nessuno mangiare o bere alcunch√© per strada, nonostante sia pieno di negozi che vendono roba da portar via. Indagher√≤.
Stasera, quindi, ho tentato il gran colpo: ho provato il mercato del cibo del supermercato Esta, sotto la stazione. E’ come fosse un piano di Rinascente occupato da banchetti che vendono cibo fatto sul momento, di ogni genere; la cosa interessante per√≤ √® che, siccome erano gi√† le otto e un quarto e alle nove chiudevano, come in un vero mercato la roba era in svendita. Cos√¨ per circa tre euro ho portato a casa il classico contenitore a scomparti chiuso, contenente riso e bistecca da una parte, e riso e bistecca di altro tipo dall’altra. Per meno di un euro ho preso uno spiedino di pollo; per un altro euro ho preso un dolce dal gusto imprevisto (qualcosa tipo cannella) ma buono, in un’altra pasticceria self service; poi alla macchinetta ho preso il mio t√© al limone; e, avendo capito le usanze, mi sono portato tutto buono buono nella mia camera d’albergo, dove ho spazzolato ogni cosa: tutto ancora tiepido, quindi fatto da non troppo tempo, e molto buono.
Sono quindi piuttosto contento: ho dimostrato a me stesso di poter provvedere alla necessit√† pi√Ļ basilare, quella di procacciarmi del cibo, anche in condizioni estreme come queste: io, cinquemila yen in mano, e qualche centinaio di bar, ristoranti, supermercati e distributori automatici nel raggio di cinquecento metri. Per√≤ mi son tenuto le bacchette: se trovo un altro posto del genere a Tokyo, sono tranquillo.
[tags]giappone, sapporo, cibo, viaggi, mangiare[/tags]