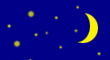Una favola politica natalizia
È un po’ che non scrivo sul blog, ma oggi è la vigilia di Natale e una mail che ho ricevuto mi ha fatto venir voglia di raccontarvi una favola. In realtà , la favola è veramente accaduta, ma dato che non mi interessa dire che Tizio è buono e Caio è cattivo, ma piuttosto trasmettervi come in ogni buona favola natalizia una morale, anonimizzerò tutto il racconto, anche se chi è pratico dell’ambiente politico cittadino riconoscerà almeno alcuni dei personaggi.
Questa favola inizia a Natale 2009, quando un giovane movimento rivoluzionario, nato sotto cinque stelle comete, si stava preparando al suo primo grande appuntamento elettorale: le elezioni regionali del marzo 2010. Tra gli esponenti più attivi a Torino, c’era un giovane trentenne esperto di marketing e comunicazione, di cui traspariva subito l’intelligenza, ma anche l’ambizione.
Personalmente penso che l’ambizione non sia in sé malvagia; e quasi tutti coloro che entrano in politica hanno ambizioni personali, un bisogno di approvazione da soddisfare, una tradizione familiare da proseguire, l’aspirazione a una fonte di reddito in più; l’importante però è che l’ambizione non vada a danneggiare la missione collettiva. In questo caso, purtroppo, l’ambizione era forte, e si tradusse in una serie di comportamenti sgradevoli; ricordo un comizio a Bussoleno in cui il giovane trentenne si offrì volontario per distribuire i volantini del Movimento alla folla, e poi scoprimmo che li dava insieme al suo santino personale. Nonostante questo, alla fine ci fu un solo eletto, e lui arrivò soltanto a metà classifica.
L’anno successivo, ci furono le elezioni comunali; e molti non si fidavano ad avere tra i candidati quella persona. Alla fine, però, il candidato sindaco era notoriamente un buono, e si decise di perdonarlo; tuttavia, fu scritto un bel regolamento che indicava a tutti i candidati cosa potessero o non potessero fare. La fiducia si rivelò infine mal riposta; la persona in questione, insieme al suo compare attivista capellone (lui mi scuserà , non lo dico in senso negativo; è che, come nei manga, per distinguere i personaggi serve un tratto visuale forte), avviò un proprio gruppo di attivisti separato, chiamandolo in modo che lo si confondesse con quello ufficiale; cominciò a fare spamming a migliaia di potenziali elettori, inviando fotomontaggi di se stesso a fianco di Grillo da cui poteva sembrare che Grillo lo consigliasse; insomma, ne fece un po’ di tutti i colori.
Oddio, visti oggi, quei comportamenti fanno sorridere; oggi, praticamente qualsiasi parlamentare ed esponente di rilievo del M5S ha una pagina personale sponsorizzata a pagamento su Facebook e uno staff proprio, e pensa soprattutto alla promozione personale. Allora, però, eravamo giovani e puri e così l’ultimo giorno di campagna elettorale, prima ancora di vedere i risultati, quella persona fu cacciata dal movimento cittadino; e non andando di nuovo oltre il quarto-quinto posto, non essendo stata eletta, così terminò l’avventura politica sua e del suo amico capellone.
Questo, almeno, era ciò che credevamo. Un anno e mezzo dopo, infatti, ci furono le parlamentarie. A Torino e provincia, nelle liste bloccate decise dal voto online, il M5S elesse sei parlamentari; e se tre di loro erano quelli che “dovevano” uscire negli auspici dei vertici, cioè staffisti del consigliere regionale da mandare in Parlamento, e altri due erano attivisti ben conosciuti e stimati, la sesta fu una sorpresa per tutti: una persona che di lavoro faceva la portinaia in un elegante stabile del centro, quello in cui abita tuttora una attivista storica e ora presidenta di commissione comunale; una persona che era sì attivista ma che non avevamo mai visto fare alcuna proposta concreta, e che nessuno pensava capace per il ruolo.
Le cose diventarono più chiare quando, subito dopo le elezioni, la neo parlamentare assunse come portaborse romano proprio lui, l’ex attivista marchettaro cacciato; si capì che era stato lui a organizzarle la campagna elettorale personale, e che ciò che non era riuscito a fare per sé l’aveva fatto per lei. Ci fu una sommossa degli attivisti, guidata da una giovane futura sindaca che in una infuocata assemblea intimò alla parlamentare il licenziamento immediato del portaborse sgradito, pena la cacciata. L’intero movimento cittadino chiese al gruppo parlamentare di cacciare la deputata; il gruppo parlamentare romano, a dire il vero, aveva già problemi suoi e se ne fregò abbastanza, ma alla fine, com’è come non è, la parlamentare finì nel primo gruppo di dissidenti, Alternativa Libera.
Anche qui, col senno di poi, la situazione era meno netta di quel che ci sembrò all’epoca; forse non ci sarebbe stato tutto questo zelo moralista se la parlamentare non fosse stata estranea al gruppo di potere dominante, e comunque i voti che prese non furono “manipolati” ma dovuti all’abile presentazione. Del resto, scoprii poi che uno degli elettori della parlamentare in questione fu addirittura lui, Gianroberto, che essendo residente a Settimo Vittone votò alle parlamentarie torinesi; mi disse che aveva votato “un no tav, una astrofisica e una operaia”, scelti tra quelli col cognome che iniziava per A o B perché non aveva avuto tempo di scorrere la pagina più sotto. Probabilmente, le bastò dunque fare un bel video e autodefinirsi “operaia” nella colonna “professione” per raccogliere abbastanza voti da entrare in Parlamento.
Tutto chiaro? Ecco, qui comincia la morale di questa storia; perché fino a questo punto i ruoli sembrano chiari, i buoni da una parte e i cattivi dall’altra. Se non che, un anno dopo, subentra in consiglio comunale un nuovo consigliere, già eletto in precedenti legislature; un ex del centrodestra transitato al centrosinistra e ora in maggioranza. Detto così, ne penserete subito malissimo; ma io faccio amicizia con tutti, e ci chiacchiero un po’.
Una volta in commissione si parla degli homeless, e discretamente viene fuori che il consigliere partecipa ad attività di volontariato sul territorio che se ne occupano. Ora, se vi dicessi i partiti per cui è transitata questa persona, sono gli ultimi a cui pensereste freghi qualcosa dei barboni o degli ultimi in generale; e invece… Ma non finisce qui: lui mi dice, io mi occupo in privato dei senza casa da tanti anni e non ho mai praticamente visto un grillino; ce ne sono solo un paio, ma li avete cacciati. Chi sono, chiedo io? Ovviamente erano l’attivista capellone e il giro del portaborse.
E qual è la morale di questa storia? Beh, è che alla fine, specialmente in politica, quelli che più parlano di aiutare gli ultimi sono spesso quelli che meno fanno in concreto, e viceversa; che però anche chi fa beneficenza in privato può comportarsi male in pubblico, provando ancora una volta che i buoni e i cattivi in senso assoluto non esistono; che comunque contano molto di più le persone del partito a cui appartengono, e giudicare le persone in base al partito di appartenenza è sbagliato; e che chi davvero vuole fare qualcosa per gli altri, più che impegnarsi in politica mirando a grandi rivoluzioni che non arrivano mai, farebbe meglio a concentrarsi sulle piccole azioni sotto casa propria. Buon Natale!
Commenti disabilitati su Una favola politica natalizia