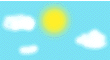La sveglia √® presto, perch√© ci eravamo iscritti al safari dell’alba: appuntamento alle 4:45 alla pompa di benzina, siamo noi quattro e un gruppetto di tedeschi. Arriva una guida nera di nome Hendrik (?) e ci carica tutti su un camioncino aperto; √® ancora buio, l’aria √® gelida e fa freddo. Ci dice subito di seguire le sue istruzioni e si scusa in anticipo: non c’√® nessuna garanzia che nelle tre ore di giro riusciremo a vedere qualche animale, men che meno che vedremo qualcuno dei tanto ricercati “Big 5” (leone, leopardo, rinoceronte, bufalo e elefante).
Certo, proprio cos√¨: usciamo dal cancello, facciamo duecento metri sulla strada asfaltata, e incocciamo in un gruppo di bufali a bordo strada. Loro sono scuri e difficili da vedere, ma con le torce riusciamo a illuminarli: hanno un’espressione misteriosa e una faccia che sa davvero di preistoria. Attraversano la strada, si infilano nella boscaglia e spariscono; cinque minuti e prima crocetta sulla scheda.
Proseguiamo in un paesaggio meraviglioso: comincia piano piano a far luce sulla savana selvaggia, cos√¨ come √® da migliaia di anni, ma in fondo in fondo le colline sono puntinate di luci che brillano (siamo ai confini del parco, e quelle sono le casupole dei neri che abbiamo visto il giorno prima). Tempo di svoltare sulla strada sterrata, ed ecco una scena fantastica: tre leonesse e un leopardo. Non svelo il mistero su cosa facessero, perch√© dei leoni voglio parlarvi pi√Ļ in dettaglio nei prossimi giorni: li abbiamo visti tre volte e tutte e tre le volte sono state scene memorabili; un condensato di vita essenziale. Per√≤, dieci minuti e tre crocette!
Siamo rimasti mezz’oretta l√¨, poi abbiamo proseguito; nelle tre ore di giro – nel raggio di quindici chilometri dal campo – abbiamo poi incontrato ancora due o tre gruppi di rinoceronti, svariate giraffe, varie marche di gazzelle ovunque (dopo mezz’ora non le guardi nemmeno pi√Ļ), l’uccellino azzurro, l’uccello imbecille (che meriter√† pure lui un post a parte) e un’aquila pescatrice. I rinoceronti sono altrettanto impressionanti: sono bruttissimi e non si capisce come facciano a tenere su la testa, per√≤ quando un gruppo di una decina di loro, a tre metri dal veicolo, ha cominciato a puntarci, parecchi hanno avuto paura. Le giraffe, invece, sono animali fantastici: √® un po’ come se avessero preso un cavallo e gli avessero stirato le gambe e il collo, per√≤ sono eleganti, pacifiche, dolcissime mentre mangiucchiano foglie incuranti di tutto il resto.
Torniamo al parco assolutamente estasiati e festeggiamo con una ricca colazione a buffet all’inglese (compreso un ottimo spezzatino di fegato di animale misterioso). Il tempo di liberare le capanne e di insegnare alla cameriera come si fa il cappuccino e ripartiamo da Pretoriuskop: sono le dieci e dobbiamo uscire a met√† pomeriggio dall’altro lato del parco, a Crocodile Bridge.
Ora, sarebbe bello raccontarvi tutta la giornata, ma non vale la pena di farlo senza le tonnellate di foto; comunque, il viaggio √® memorabile, in mezzo all’infinit√† della savana, su cui ogni tanto, dall’alto di una collina, si aprono panorami indimenticabili. Nelle ore calde √® difficile vedere animali, per√≤ ogni dieci minuti succede lo stesso, magari sotto un albero o in fondo a una valletta. E cos√¨, abbiamo visto un po’ di tutto.
Le cose che pi√Ļ colpiscono della savana sono due. La prima √® la convivenza insieme alla rarefazione: la savana √® infinita, e gli animali tra loro sono in realt√† piuttosto separati. Alcuni animali sono territoriali (come leoni e leopardi), altri si spostano, ma si ha l’impressione che i vari gruppi siano sempre abbastanza lontani tra di loro, e che la densit√† relativamente bassa sia una delle chiavi dell’ecosistema. Allo stesso tempo, colpisce la convivenza: io immaginavo che le varie specie vivessero in zone diverse, che so, gli ippopotami nei fiumi, i facoceri sotto gli alberi, gli elefanti in pianura e i leoni sulle colline. In realt√† no; sono tutti abbastanza mescolati, e nello stesso territorio convivono pacificamente decine e decine di specie anche piuttosto grandi, senza che una domini sulle altre o soggioghi il territorio come facciamo noi. Certo, il leone mangia le gazzelle, ma non si ha affatto l’impressione di una guerra; stranamente, pare un ammazzamento pacifico, come se la gazzella sapesse che, tutto sommato, diventare hamburger √® il motivo per cui sta l√¨.
L’altra cosa √® il contrasto che si vede con l’esterno, particolarmente stupefacente ai bordi del parco. Semplicemente per via della recinzione e della protezione accordata dall’uomo, di qui della rete c’√® savana; di l√¨ ci sono prati, campi coltivati, paesi all’europea oppure distese di casupole. Noi tendiamo ad avere l’impressione che l’Europa, senza di noi, sarebbe pi√Ļ o meno simile: cio√®, non ci sarebbero le case e le strade, e ci sarebbero prati al posto delle coltivazioni, ma poi cambierebbe poco. Nulla di pi√Ļ sbagliato: in realt√†, ci sarebbero probabilmente o una foresta intricatissima, o la giungla, o un quasi deserto come la savana. I prati, gli alberi isolati e il verde sono una costruzione artificiale, imposta dall’uomo mediante migliaia di anni di irrigazione; qui lo si vede benissimo, tanto √® vero che ai bordi estremi del parco spuntano improvvisamente in mezzo alla terra arida degli alberi verdi, invece che secchi e contorti, alimentati dall’umidit√† generata dall’irrigazione della valle vicina. Insomma, il comando “Irrigate” di Civilization ha veramente un effetto profondo; lentamente, ha cambiato completamente la faccia del pianeta.
L’attraversamento del Kruger √® lentissimo: il limite √® di cinquanta orari, ma tanto ogni cinque minuti ti fermi perch√© c’√® qualcosa da vedere, per cui la media effettiva √® attorno ai 20-25 km/h. Accosti, apri il finestrino (fuori ci sono quasi quaranta gradi, pochi perch√© qui √® inverno) e guardi, scatti foto, filmi. Durante la giornata abbiamo visto varie volte tutti gli animali, completando man mano tutte le crocette: un gruppo di facoceri furiosi sotto un albero, e un altro gruppo nella loro tana scavata nella terra; gli avvoltoi che danno da mangiare ai figli nel nido in cima a un albero; gli ippopotami nascosti nel fiume, oppure distesi sulle rocce accanto al laghetto (artificiale, creato per facilitare l’abbeverata) a prendere il sole; lo gnu che sta l√¨ e non fa niente; le zebre in mezzo alla boscaglia; i fenicotteri sulla riva dello stagno; scimmie e babbuini di ogni genere che saltano tra gli alberi o chiacchierano in terra, con i cuccioli che giocano in mezzo alla strada; e infine, quando ormai cominciavamo a dubitare, gli elefanti, in giro a bere e mangiare sulla riva piena d’erba del fiume Sabie. Erano un po’ lontani, ma li abbiamo visti comunque bene, mentre tiravano su l’erba con la proboscide.
Tutto questo √® inframmezzato dai campi; circa ogni cinquanta chilometri ce n’√® uno, dove ci si pu√≤ fermare, uscire dalla macchina (per quello ci sono anche alcune aree sosta in giro), mangiare e, prenotando, dormire. Skukuza √® il capoluogo del parco, ed √® praticamente una citt√† di capanne; c’√® persino una biblioteca. Lower Sabie, invece, √® un insediamento pi√Ļ nuovo con uno spettacolare ristorante-balcone sul fiume. Crocodile Bridge √® stato attraversato di corsa, quindi non vi saprei dire… infatti a un certo punto, complici anche i lunghi e ripetuti bio-break femminili, eravamo a rischio di restare chiusi nel parco. Noi eravamo esausti, le batterie degli apparecchi elettronici pure, e quindi abbiamo accelerato un po’; solo che poi, vuoi non fermarti a fotografare la giraffa sullo sfondo del tramonto? Siamo arrivati in fondo solo alle 17:30, mezz’ora prima della chiusura; io ho fatto tutte le mie macumbe e sono riuscito a mantenere la macchina fotografica attiva fino a cinque chilometri dall’uscita.
E naturalmente, l’esperienza pi√Ļ pazzesca di tutte ci √® capitata a cento metri dal cancello d’uscita, e ne rimane solo una unica foto sfocata fatta con una macchinetta semplice semplice.
Ma per quel racconto dovrete aspettare ancora un paio di giorni!
P.S. I costi: dodici euro a testa l’ingresso nel parco; nove euro a testa la capanna per la notte; tredici euro a testa il safari dell’alba; quindici euro cena abbondante al ristorante, dieci euro colazione abbuff√© (in alternativa, bar o provviste e cucina: ci sono anche fornelli comunitari). Sto seriamente pensando di mettere in piedi un gruppo safari per l’estate 2009…
[tags]viaggi, africa, sud africa, kruger, safari, savana[/tags]